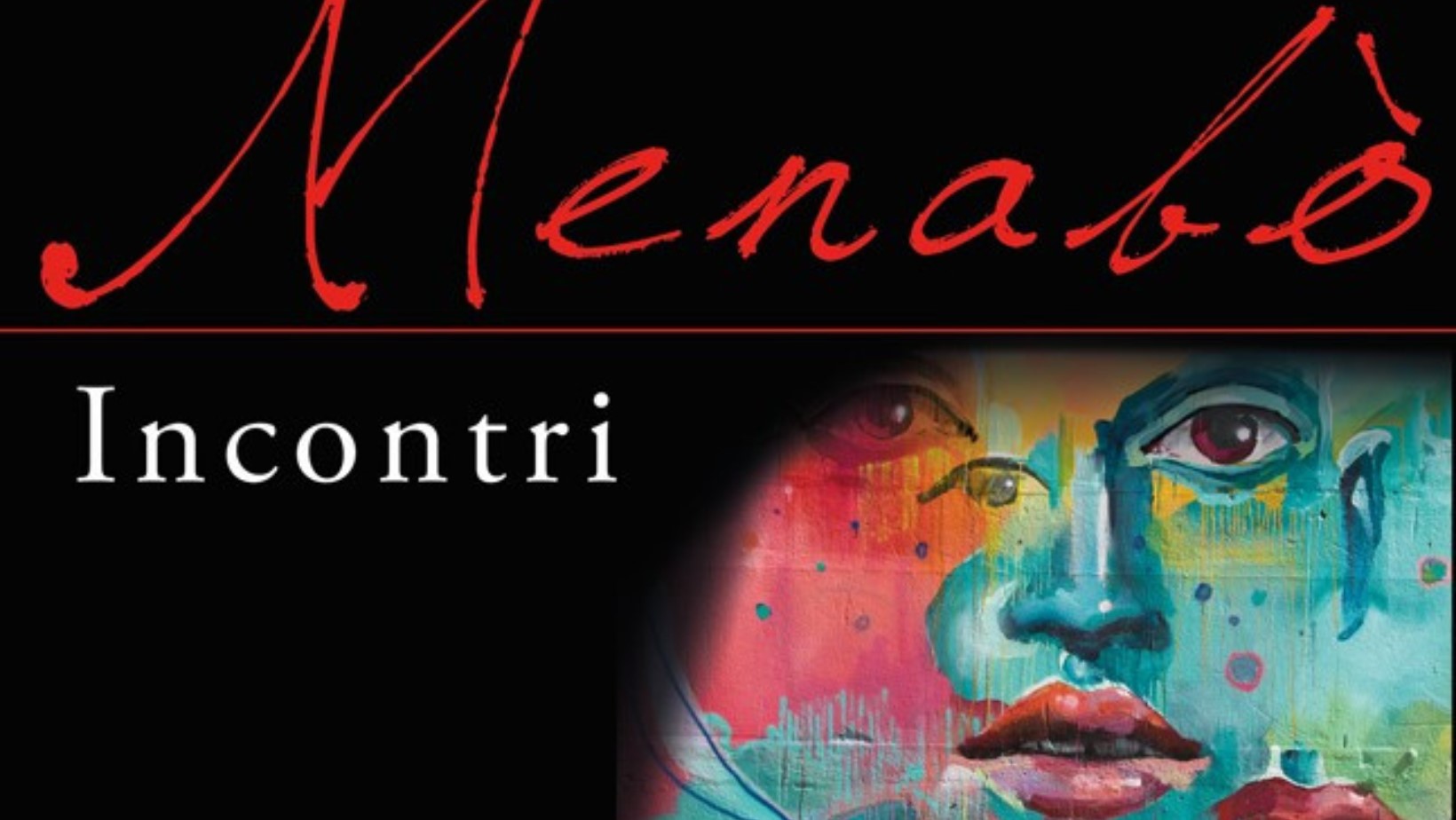Una sentenza lapidaria, una verità nota eppure sottaciuta, un mantra che dovremmo incidere a caratteri cubitali sulle pareti delle nostre anime stanche: Il lavoro non ti ama. È questa la breve ma efficace frase che dà il titolo al saggio della giornalista americana Sarah Jaffe (qui la recensione), un’indagine sulle condizioni professionali e di vita di migliaia di lavoratori in tutto il mondo, uniti dal filo ormai non più così sottile del capitalismo.
Tradotta in Italia da Rocco Fischetti per minimum fax, la lunga attività di ricerca di Sarah Jaffe nasce nel 2012, ma trova la sua più completa definizione negli anni della pandemia, quelli in cui il nostro modo di approcciare al lavoro è cambiato repentinamente, forzando le porte chiuse di appartamenti sin troppo piccoli per portarci dentro altro carico di stress e scadenze, nonché la convinzione che, finalmente, l’ordine precostituito potesse essere sovvertito. Sovvertite, invece, sono state le nostre vite, fuorviate, plagiate, plasmate dall’inganno di una terra promessa. Quella dell’indipendenza.
Con lo scoppio del coronavirus, il lavoro, per molti, si è fatto virtuale. È successo quando la tutela della salute pubblica ci ha impedito di recarci in ufficio, di indossare gli abiti buoni non soltanto a mezzo busto; quando, tra il pane da far lievitare e i bollettini di contagio quotidiani, altro non abbiamo fatto che cercare un modo per dimenticarci di vivere, convinti di star iniziando a farlo forse per la prima volta. Da un lato, infatti, abbiamo scoperto il tempo: il tempo del fare e il tempo del non fare; il tempo per rimetterci in gioco e il tempo per sperimentare una quotidianità diversa, più lenta, meno mortificante, bugiardamente più vera. Dall’altro, abbiamo scoperto l’imprendicariato, la condizione, così chiamata da Silvio Lorusso, che accomuna imprenditori e precari, ognuno spinto o costretto a improvvisare una mentalità aziendale per non soccombere.
Tantissime figure hanno dovuto reinventarsi, fare da sé, fare per sé, pur di garantirsi una qualche forma di guadagno a cui nessuno stava pensando per loro. Creator digitali, influencer, rider, freelance, spesso veri e propri professionisti o esperti dei settori più disparati (e disperati) hanno intrapreso carriere diverse, modalità di approccio all’impiego meno classiche, più pericolosamente contemporanee. Tutti sono stati mossi da una necessità, quella alla sopravvivenza, e da un’altra non trascurabile convinzione: la possibilità, finalmente, di farsi imprenditori di se stessi. Il lavoro ha iniziato a essere raccontato come passione, svago, hobby, un filtro che ha fatto svanire, in noi, l’idea del diritto, della tutela, di una condizione dignitosa cui aspirare e pretendere. L’idea del se vuoi, puoi, ma se non puoi, sei soltanto un fallito.
Social, lavoro, vita privata: negli ultimi anni, tutto è diventato necessariamente ostentazione dei nostri successi professionali. In assenza di altro, il lavoro ha smesso il suo ruolo di attività che, ridotta all’osso, dovrebbe soltanto servirci a pagare le bollette per mutarsi nello strumento che ci permette di costruire la migliore versione di noi stessi, quella da vendere al mercato delle relazioni sociali per scalare la classifica o, quantomeno, per provare a esserci. Esserci dal punto di vista digitale, immateriale, là dove il nostro capo è un algoritmo, la tecnologia invade lo spazio vitale e si fa sorveglianza: di input, di idee, di sogni, di fragilità.
Come scrive Sarah Jaffe, per tenerci separati, il capitalismo deve controllare i nostri affetti, la nostra sessualità, i nostri corpi. E per farlo deve convincerci che il lavoro è il nostro più grande amore. Una questione che è stata a lungo materia di speculazione, anche filosofica, e che forse soltanto oggi si rivela in tutta la sua dannosità.
È intorno a queste riflessioni che ruota l’intera indagine della giornalista americana, un’accurata analisi che mette in luce le storture della modernità, indagandone le cause e gli effetti sociali, individuali e professionali. Ed è da qui che partirà anche l’evento Donne e lavoro tra Italia e USA, organizzato dall’VIII Municipalità di Napoli, dalla casa editrice minimum fax e dal Coordinamento Femminista Nazionale La Città delle Donne. Un incontro che si terrà a Napoli il prossimo 13 gennaio, ore 17, presso la Sala Consiliare della Municipalità di Scampia (Largo Cittadinanza Attiva 15), in presenza di Sarah Jaffe, Nicola Nardella (Presidente dell’VIII Municipalità), Melinda Di Matteo (Coordinamento La Città delle Donne), e della ricercatrice giuslavorista Sofia Gualandi.
Seguiranno gli interventi di Rosario Andreozzi (Comune di Napoli), Patrizia Mincione (Consiglio VIII Municipalità e Comitato Vele), Maria De Marco (già Assessora alle Pari Opportunità dell’VIII Municipalità), Patrizia Palumbo (Associazione Dream Team – Donne in Rete) e Francesca Borghese (USB Campania). Chiude l’evento il contributo di Chiara Rea (minimum fax). Modera la giornalista Monica Di Sisto.
Un appuntamento importante, dunque, occasione di confronto e riflessione su temi che richiedono urgenza di intervento e discussione, e che, forse, in una città come Napoli trovano accezioni e significati diversi. Se, infatti, il mondo descritto da Sarah Jaffe racconta la contemporaneità, il capoluogo campano e la sua periferia vivono ancora nella morsa di un tempo che in molti altrove non è più.
Basti pensare al fenomeno delle grandi dimissioni, alla quitting econonomy che, dalla primavera del 2021, riguarda tutte quelle persone che stanno lasciando volontariamente il loro lavoro. Negli USA si è battuto il record dei quattro milioni di persone; in Europa, la situazione è appena diversa, con numeri inferiori ma comunque interessanti. Il malessere è diffuso e trasversale e riguarda tutti, pure chi non può permettersi di licenziarsi. Riguarda anche l’Italia, dove il fenomeno è ancora di importazione ma negli ultimi nove mesi del 2021 ha coinvolto più di un milione di lavoratori che hanno scelto di non continuare a farsi del male, nonostante l’altissimo tasso di disoccupazione nel nostro Paese – il solo, in Europa, dove gli stipendi sono diminuiti negli ultimi trent’anni – e la condanna a qualsivoglia forma di assistenzialismo. Non riguarda Napoli, però, dove il lavoro ancora si cerca.
La Campania è, infatti, la regione d’Italia con il tasso di disoccupazione più alto (19,3%), superando, nel Mezzogiorno, la Calabria e la Sicilia. Il tasso di disoccupazione europeo — secondo l’ultima rilevazione Eurostat — è del 6%. In particolare, le previsioni economiche per il 2023 raccontano che nella regione un tempo fertile ci saranno circa 11054 disoccupati in più, con la provincia di Napoli che registrerà il maggior incremento (+ 5327 unità). Dati che, ovviamente, subiscono un’impennata quando abbracciano l’universo femminile. Le donne che lavorano meno – in termini occupazionali, non di impegno –, che guadagnano meno e che sono relegate sempre e comunque al loro ruolo di madri, figlie, mogli, compagne, sorelle. Al lavoro di cura, l’unico garantito loro e che, purtroppo, non conosce crisi.
Margaret Thatcher diceva: «There Is No Alternative». Non c’è alternativa. Ed è questo che ancora oggi siamo portati a credere, che non ci sia alternativa. Così, se prima si scioperava per lavorare meno e meglio, oggi il lavoratore si ritrova a rivendicare il proprio sfruttamento con il pretesto della sopravvivenza. Incontrarsi, però, serve proprio a questo: a trovare una via altra. Perché se il lavoro non ci ama, è l’amore la morte del capitalismo.