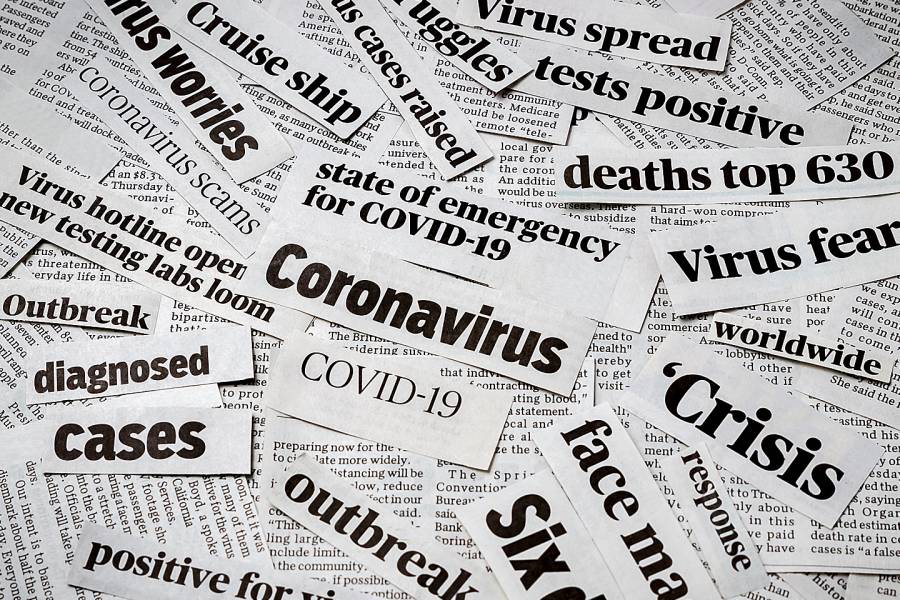1989. Partimmo dopo Natale nella delegazione della CGIL Nazionale che contribuì a portare, assieme ad altre organizzazioni internazionali, 1500 persone a Gerusalemme a manifestare per il conseguimento della pace tra i due popoli che abitano quella terra.
A costruire con infinita pazienza quella manifestazione storica avevano lavorato per mesi Chiara Ingrao, Luisa Morgantini e Tom Benettolo, dell’Associazione per la Pace. Erano riusciti a costruire, assieme all’organizzazione pacifista israeliana Peace Now e ai palestinesi, un diario condiviso delle tappe di quei giorni che tutti pensavano sarebbero passati alla storia, aprendo la stagione della pace sulla base della convivenza in due Stati dei due popoli. Il racconto emozionante e partecipato di quei mesi costellati da speranze e improvvise delusioni, di strappi e ricongiunzioni lo si può leggere, a firma di Chiara Ingrao qui: https://diazilla.com/doc/882084/2°-capitolo—chiara-ingrao.
Il concetto di fondo che doveva guidare i nostri passi in quella terra era che eravamo ospiti dello Stato di Israele che, fino all’ultima riunione, aveva voluto contrattare cosa poter visitare e chi poter incontrare dei palestinesi: allora Gerico e Betlemme sì e poi, solo dopo una lunga trattativa, anche Ramallah e Hebron, ma solo in piccoli gruppi sotto scorta. Gaza – già allora ferita purulenta dell’occupazione militare – non se ne parla nemmeno. Tutte le visite, gli incontri, la raccolta delle testimonianze dovevano essere all’insegna della non-disparità: cominciammo con il visitare lo Yad Va Shem, il Museo dell’Olocausto. e finimmo con l’incontrare un “colono” venuto dall’Italia ad abitare la Terra Promessa che, con aria ispirata, ripeteva come un mantra: «È tutto scritto: questa terra appartiene al popolo eletto».
Mi viene da ripensare a quei giorni indimenticabili mentre i missili sganciati dagli F35 con la stella di David, acquistati dai consorzi occidentali dei quali fa parte l’Italia, colpiscono Gaza: quaranta kilometri di lunghezza e dieci di larghezza abitati da un milione e 800mila persone, con una densità abitativa di 5mila persone per kilometro quadrato, i cui confini sono sigillati da filo spinato e muri di cemento controllati dall’esercito e il cui tasso di povertà è vertiginosamente alto.
Nel 1989 in partenza per Gerusalemme lasciavamo un’Italia nella quale la questione palestinese era al centro della solidarietà militante della “sinistra”. In tutte le Feste dell’Unità, lo stand dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina era meta di incontri e dibattiti partecipati e coinvolgenti, fra i gadget la Kefiah palestinese contendeva il posto del più gettonato al ritratto di Che Guevara.
D’altronde, Berlinguer aveva stretto in un abbraccio Yasser Arafat e Craxi, nel suo memorabile discorso del 6 novembre del 1985, aveva dichiarato la legittimità della “resistenza armata” del popolo palestinese, guidato dall’Olp. Andreotti praticava l’equa-vicinanza, come la chiamava lui, che si concretizzava con un console italiano a Gerusalemme con evidenti simpatie palestinesi – e che si mostrò, in quei giorni di dicembre, solerte e premuroso nei confronti dei manifestanti – e con un ambasciatore a Tel Aviv esplicitamente schierato con le “ragioni” di Israele. Quando, su invito di Yasser Arafat, Marisa Manno, sua madre e io volammo a Tunisi per essere ricevuti dal Consiglio dell’Olp, non casualmente fummo accompagnati da Giorgio Napolitano e un giovanissimo Gianni Cuperlo.
Parlava volutamente proprio di “resistenza” Bettino Craxi: la resistenza a un’occupazione militare, che, come tutte le occupazioni da parte di una potenza “straniera”, è fatta di arroganza e provocazioni, di minacce e di violenza gratuita, di sfoggio di potere e di prevaricazioni piccole e grandi ma sempre quotidiane.
Tornati l’anno dopo, potemmo guardare tutto quello che era stato nascosto sotto il tappeto in quei giorni esposti all’opinione pubblica internazionale. Vedemmo i posti di blocco, dove senza uno straccio di giustificazione un palestinese può essere fermato per ore quale che sia il motivo del suo passaggio: finendo con il partorire lì per terra senza poter raggiungere l’ospedale o spirare in auto senza poter raggiungere il respiratore meccanico. Incontrammo, scendendo le scale della Gerusalemme araba, gruppi di giovanissimi ebrei con la Kippah in testa e l’Uzi sulla spalla che si divertivano a prendere a calci le ceste delle vecchie donne arabe sedute a vendere verdura sulle scale, oppure le pattuglie di militari che ti puntano il fucile sul petto se ti vedono con la macchina fotografica in mano e aspettano che tu fugga intimorito.
Sono passati più di trent’anni da quelle visite: la situazione nei territori occupati non è cambiata, è solo peggiorata; Gaza è ancora più povera, logorata da un embargo disumano che toglie cibo e medicine (anche i vaccini) alla popolazione e, resettato l’obiettivo dei due popoli in due Stati, non si intravede uno straccio di soluzione che possa garantire stabilità sull’equilibrio dei rispettivi interessi nazionali.
A me, testimone oculare di quelle vicende e di quelle situazioni, sembra piuttosto cambiata l’Italia, il suo personale politico e il mondo dell’informazione innanzitutto. Ringrazio, perciò, la redazione di Mar dei Sargassi che ospita questo mio contributo come testimonianza della volontà, preziosa perché sempre più rara, che la semplificazione delle situazioni complesse giova solo alla propaganda e mai all’informazione.
Dal blog Contame:
Gerusalemme
Di quella giornata ricordo i colori. Il caldo. E la luce.
La luce che faceva brillare quelle mura agili e robuste volute da Saladino il Magnifico nel 1500 e che circondano la città. Circondare simbolicamente la città: questo avremmo voluto fare noi unendo tutte le mani, le braccia, i cuori e le volontà di pace delle persone venute quel giorno di un dicembre incredibilmente caldo dell’anno delle speranze, delle illusioni, delle utopie: il 1989.
Sì: una catena umana formata da palestinesi, israeliani e dai millecinquecento pacifisti venuti dall’Occidente con il loro carico di fiducia nella possibilità di essere i fautori di un accordo di pace che sancisse per sempre una convivenza di due popoli in due Stati limitrofi.
Colori. Delle magliette a mezze maniche che tutti indossavamo coprendo pelli di colori e sfumature diverse, dei sai dei frati francescani, guardiani del Santo Sepolcro, delle vesti delle donne arabe, dei capelli delle famiglie multicolori che erano venute fin lì da posti lontani. Ricordo una famiglia scozzese, padre, madre e due marmocchi tutti con i capelli rossi, gli occhi chiari e un largo sorriso felice stampato in faccia.
Noi avevamo lasciato nostra figlia Verena, che aveva dieci anni, in Italia, sulle Dolomiti in un asilo estivo “ottimista e di sinistra”.
Stringemmo le mani anche noi. Ci capitarono accanto i frati, sorridevano sereni. Tutti tenevamo a bada l’inquietudine per quell’equilibrio precario su cui era stata costruita la possibilità stessa di manifestare: le autorità israeliane non l’avevano vietata né autorizzata, il Primo Ministro Shamir l’aveva paragonata a una manifestazione per esprimere il consenso alle Brigate Rosse, il governatore della città Kollek aveva espresso la sua contrarietà.
Eppure, intorno a mezzogiorno, a Gerusalemme, trentamila persone, quel 30 dicembre del 1989, congiunsero, per una manciata di secondi, la loro fiducia che la storia di quel conflitto potesse miracolosamente svoltare.
Poi il tempo cominciò a correre.
Sentimmo i botti inconfondibili dei lacrimogeni. Rientrammo per la Porta di Damasco nella parte araba della città. Marisa scelse di tornare subito in albergo. Rimasi a vedere la polizia a cavallo che caricava e manganellava tutti quelli che erano a tiro.
La luce era abbagliante. I caschi dei poliziotti risplendevano. Colori, tanti e più di tutti: il rosso del sangue, il marrone chiaro del manto dei cavalli.
Tornai in albergo. La hall era al piano ammezzato, un grande finestrone a parete dava sulla strada dove poliziotti e soldati inseguivano giovani che cercavano di scappare, gli ospiti dell’albergo si accalcavano per guardare, molti avevano il naso e le mani appoggiate sul cristallo. Qualcuno di noi gridò uno slogan. Rapidamente una specie di autoblindo sormontata da idranti puntò verso quell’albergo, quel finestrone. E sparò un potentissimo getto d’acqua.
Il cristallo volò in mille pezzi.
Urla. C’era sangue. Marisa stesa a terra. Si fece largo qualcuno dicendo «sono un dottore». Si chinò su di lei e gridò: «Dio, l’occhio è tagliato!».
Da quel momento, i ricordi diventano frammenti vivissimi in una nebbia di irrealtà.
Poliziotti e soldati impedivano di far arrivare autoambulanze o di lasciare l’albergo. Vidi un turista, ospite dell’albergo, che si fece largo e scese in strada. Seppi dopo, molto dopo, che era un ufficiale di grado elevato della polizia danese, o forse olandese, che si qualificò e chiese con forza che arrivasse un mezzo di trasporto qualsiasi per trasportare una donna ferita gravemente all’ospedale.
Arrivò un pick up con due ragazzi arabi alla guida. Marisa fu stesa sul cassone e portata via in fretta.
Poi la corsa all’ospedale. Anche esso arabo: dei Cavalieri di Malta.
Un dottore mi chiede l’autorizzazione ad asportare l’occhio tagliato perché c’è il rischio di perdere anche l’altro.
Marisa Manno è operata nel pomeriggio. E poi nella notte gli agenti del Servizio di Sicurezza Israeliano vengono a interrogarla. Lei risponde lucida e fredda.
Poi inizia un’indimenticabile processione: per primi i frati francescani. Poi i pacifisti italiani.
E poi, dalla mattina successiva, i palestinesi di ogni età ed estrazione sociale. Donne, tantissime e di tutte le età, con scialli e mantelli coloratissimi. Maestre con i loro bambini, i deputati arabi alla Knesset, vecchi malandati che si appoggiano sui bastoni, ragazzi dell’Intifada con il volto coperto dalla Kefiah.
Tutti portano qualcosa, messaggi, fiori, piante, stoffe, i bimbi recitano poesie, le donne cantano inni, madri con i volti segnati dal tempo passato nel dolore portano in regalo i quadri dei propri figli “martiri”, si fermano accanto al letto e guardano quella benda e sono certo che nel loro animo si rinnova il dolore.
L’intera corsia è svuotata di tutti gli altri pazienti per far posto a quella coloratissima mercanzia deposta ai piedi della donna che ha perso un occhio per una causa giusta, la causa della pace, la causa del popolo palestinese.
E poi tutto diventa frenetico: la CNN viene a intervistare Marisa, il console italiano a Gerusalemme viene a rassicurarci, poi la partenza, le telecamere a Fiumicino a inquadrare la mamma di Marisa che l’abbraccia – «Figlia sono orgogliosa di te» – a casa di Mario Ruggiano sulla Nomentana e Pietro Ingrao commosso che stringe a lungo la mano di Marisa, la cittadinanza palestinese onoraria, l’invito di Arafat e il viaggio a Tunisi con Giorgio Napolitano e un giovanissimo Cuperlo, gli onori del Comitato Centrale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, infine a Napoli e il pellegrinaggio della comunità palestinese a casa nostra, i cento pranzi e cene con gli odori e i colori delle spezie arabe affratellati, nei piatti, ai sapori “veraci” delle pietanze napoletane.
Tornammo l’anno seguente a Gerusalemme e stavolta Verena venne con noi.
Percorremmo insieme gli acciottolati della città araba, io rividi quei colori intensissimi e cercai, visitando i simboli delle tre religioni monoteiste, che distano pochi passi l’uno dall’altro, di immergermi in quella sacralità che si respira nell’aria e che rende Gerusalemme una città assolutamente unica, un patrimonio che appartiene all’umanità intera, credente o meno, una tappa obbligata di una qualsiasi ricerca spirituale.
Per quanto riguarda quel 30 dicembre 1989 ci vorranno mesi, e le denunce, e un regolare processo, per dimostrare che la violenza era venuta solo dalla polizia, e, dirà la sentenza, «ingiustificata e sproporzionata». Nel 1992, verrà finalmente risarcita anche Marisa: un occhio perduto per sempre, vale 115 milioni. Motivazione del risarcimento: incidente stradale.
Dopo, rimarrà quel vuoto sotto la palpebra. Appartiene a noi tutti, ma è solo Marisa a conviverci: ancora oggi. – da Salaam Shalom di Chiara Ingrao
Un contributo a cura di Pierluigi del Pinto