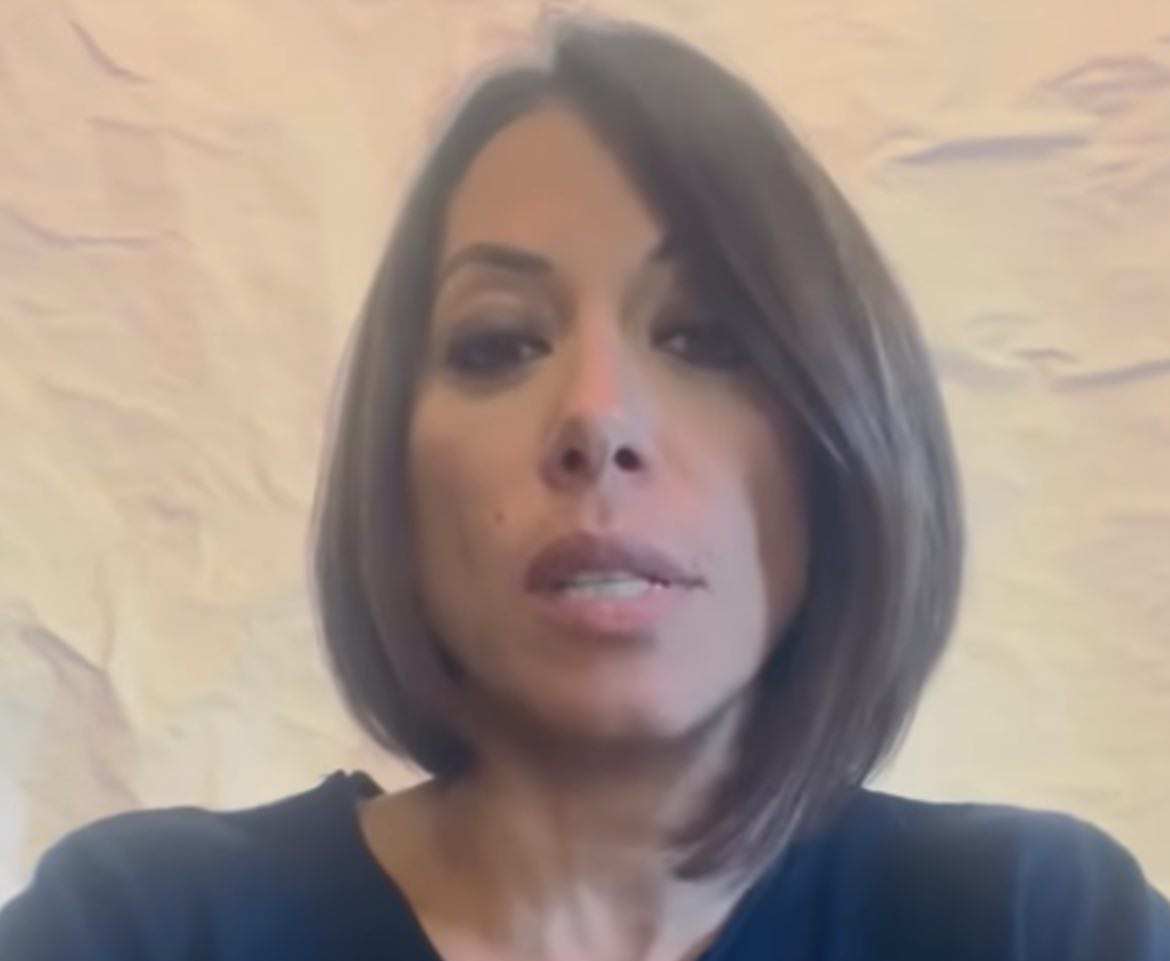Natale, tempo di compere. Fuori si gela. In un grande magazzino due persone stanno parlando: «La mamma dice che sei senzatetto» afferma una ragazzina bionda. È preoccupata, la signora brizzolata a cui si rivolge è stata la sua tutor. La donna sorride: «No, sono senzacasa, non senzatetto; non è la stessa cosa». È una delle prime scene di Nomadland, il film che ha dominato l’award season del 2021. Nata dal libro investigativo della giornalista Jessica Bruder, la pellicola racconta una realtà ai più sconosciuta: quella dei nomadi americani, anziani che, non potendo permettersi né una casa né la pensione, percorrono l’America con i loro van alla ricerca di impieghi stagionali.
Un anno è passato da quando il film è stato proiettato nei cinema e molte cose sono cambiate. In primis, la frase houseless, not homeless è stata adottata dalla comunità nomade come motto. Un tentativo, con l’aiuto della pellicola, di distaccarsi dall’etichetta consolidata dei senzatetto.
Clochard, vagabondi, nomadi. Prima barboni, hobo, zingari. E, ancora, mendicanti, pellegrini, raminghi. Tante sono le parole che abbiamo utilizzato, nei secoli, per definire chi non ha una casa. Le abbiamo confuse, sovrapposte e poi cambiate per renderle meno denigratorie. Mai, però, ne abbiamo compreso appieno il senso, né ci siamo liberati della diffidenza che ci ispirano. Dopotutto il conflitto tra nomadismo e sedentarietà è antico, così tanto da essere l’origine del primo omicidio: quello di Abele, figlio di Eva e Adamo.
In tutte le versioni del mito, Abele è un pastore, mentre suo fratello Caino – il suo assassino – è un agricoltore. Secondo la lettura di Francesco Careri nel suo Walkscapes, i due fratelli rappresentano due modi di vivere, quello della caverna e dell’aratro che scava nelle sue viscere, e quello della tenda che si sposta sulla superficie terrestre senza lasciare tracce del proprio passaggio. Sono lo spazio dello stare e lo spazio dell’andare, così opposti da generare un fratricidio.
Ironicamente, sarà Caino a diventare un vagabondo. Dopo l’omicidio, Dio gli ordinerà di essere per sempre un fuggiasco, e di errare su tutta la terra. Il girovago assume per la prima volta il connotato di reietto, assassino, trasgressore. Quest’ultimo marchio – trasgressore della legge divina o umana – non lo perderà mai.
La città, nell’Alto Medioevo occidentale, diventò un presepe in cui ognuno occupava un preciso ruolo, dal fornaio al maniscalco, secondo gerarchie predeterminate. Chiunque rigettava la città, ne rigettava anche l’ordine, le leggi, i rituali. Proprio come i goliardici o clerici vagantes, intellettuali vagabondi che giravano tra le università d’Europa facendo i giocolieri. Pellegrini e cavalieri, seppur erranti, mantenevano un ruolo sociale incasellato nelle dinamiche cittadine. I goliardi no, rifiutavano le caste medioevali e le prendevano perfino in giro nei loro poemi satirici, i carmina burana. Il disprezzo era reciproco e gli abitanti delle città li tolleravano a stento.
Il settimo giorno, Dio si riposò da tutte le opere che aveva portato a termine. Con queste parole, la Genesi segnò il destino dell’umanità. Sei giorni di lavoro, uno di riposo, così doveva vivere il giusto per conquistare il regno dei cieli. Nel nostro immaginario, la Chiesa è benevola verso i mendicanti, i poveri e i vagabondi, li nutre e gli accoglie. In realtà, è la responsabile storica dell’intolleranza verso i diversi. Dall’Alto Medioevo in poi, e in particolare nel Rinascimento, la Chiesa si convinse dell’importanza morale e teologica del lavoro e bollò chiunque non vivesse del suo sudore come un parassita. Vennero soppressi gli ordini mendicanti, eliminati i goliardi e rilasciate patenti ai pellegrini per distinguerli dalla massa di trasgressori. Nel Cinquecento, la bolla papale Quamvis infirma stabilì che solo ciechi, vecchi e inabili potessero avere il permesso di mendicare e solo a loro veniva concesso uno stemma da cucire sui vestiti. A tutti gli altri, i vagabondi, spettavano le frustate e la galera.
Non lavorare, ozioso vagare senza uno scopo preciso, intenzioni criminali, non avere fissa dimora e mendicare: queste erano le caratteristiche del vagabondo. Ovviamente, in questo profilo rientrarono anche i popoli romaní, i cosiddetti zingari o gitani. Si tratta di popoli storicamente nomadi, che nel Medioevo si sono inseriti nel contesto fortemente urbanizzato europeo. Bollati come genia di gente vagante colma di ogni empietà, i popoli romaní subirono arresti di massa, espulsioni forzate, impiccagioni e schiavitù. Un’epopea di persecuzioni culminata nei triangoli marroni del nazismo, che diventavano blu nel caso di apolidi e migranti.
L’odio verso i senzacasa non è però un qualcosa rimasto nei secoli passati. Clochard, rom e migranti sono la triade del degrado, onnipresenti nei discorsi dei partiti reazionari. Tre identità totalmente differenti, ma accomunate perché dei vagabondi, degli errori nella perfezione dell’ordine cittadino.
Il vagabondo, però, non è l’unico senzacasa del nostro immaginario. Esiste un archetipo più amato, rispettato, che non suscita disprezzo. È il viandante, una figura ambivalente. Si tratta di una persona generalmente agiata, colta, che abbandona la sua comoda routine per vivere all’avventura. Il viandante sul mare di nebbia, la spettacolare opera di Caspar David Friedrich, ne è il manifesto: un uomo elegante, dai capelli scompigliati dal vento, con lo sguardo perso nell’infinito.
La figura del viandante viene rilanciata nel ventesimo secolo dai classici non-fiction di Jon Krakauer e Jack Kerouac: Into the Wild e Sulla Strada. Entrambi i protagonisti – Alexander Supertramp e Jack Kerouac stesso – sono studenti universitari, intellettuali e borghesi, che scelgono all’improvviso di abbracciare la vita nomade. Ma perché? Spesso, per puro spirito di avventura. In altri casi, diventare viandante è stata una fuga da qualcosa di paralizzante e soffocante.
Sulla Strada di Kerouac diede vita alla gioventù bruciata, un movimento giovanile anticonformista emergente dell’underground newyorkese. Era il secondo dopoguerra e i giovani avevano bisogno di una via d’uscita. L’orrore del conflitto mondiale era ancora fresco e le nuove generazioni volevano costruire qualcosa di diverso. Perciò, si lanciavano nelle lunghe autostrade degli States, superando i limiti e le regole di una società che li aveva delusi.
La gioventù bruciata è stata una cultura figlia di quella hobo, sviluppatasi invece a fine Ottocento: anche i giovani hobo erano reduci da una guerra – quella civile, seguita da una forte recessione – e, impoveriti e disillusi, saltavano su treni merci diretti verso l’ignoto. E, ancora, la guerra del Vietnam generò una nuova cultura, quella degli hippie e dei loro scuolabus psichedelici. Queste generazioni sono diventate il manifesto del viandante ribelle, libero e anticonformista, che oggi si è reincarnato nel backpacking, nel couchsurfing, nei camperisti, nella cultura rave o nei punkabbestia.
Milioni di road-movie sono nati dalle costole di questi movimenti, alcuni più autentici, ma tanti fortemente idealizzati. La vita in camper non è una pubblicità di Levissima o di Dior Sauvage: è vero, le viste mozzafiato sono una parte dell’offerta, ma anche i parcheggi di centri commerciali e i secchi pieni di feci. Eppure, ci sono dei van che sono sempre piazzati di fronte a spiagge meravigliose e non beccano mai una tempesta o una gelata: quelli degli influencer di #vanlife.
Se curiosate tra le foto di questo hashtag, ci troverete principalmente millennials in bikini, seduti a guardare romanticamente coste incontaminate. Mai una doccia gelida, una ruota sgonfiata, un fornelletto rotto. La #vanlife non è reale: non c’è nulla di glamour e lussuoso nel nomadismo. Tutto serve per sponsorizzare camper e profili social, eppure funziona: i vanlifers, assieme ai digital nomad – lavoratori in remoto che si spostano da una località balneare all’altra – hanno reso di colpo il nomadismo uno status symbol.
Houseless, not homeless. Ma nemmeno influencer, aggiungerei. La realtà è molto diversa per chi non ha sponsor: recessione e pandemia hanno messo a serio rischio la vita dei camperisti, spesso soli, anziani e senza alcuna protezione. Molti nomadi sono sempre più poveri e ai Rubber Tramp Rendezvous – i raduni della comunità – è facile trovare i camper di lusso dei vanlifers parcheggiati accanto ad ammassi di ferraglia con a stento un materasso dentro.
Ci sono ancora camperisti, come Bob Wells – apparso in Nomadland – che raccontano la loro vita con sincerità e senza mistificazioni. Wells ha ammesso che sì, il movimento sta diventando mainstream, ma è parte della cultura nomade accettare le trasformazioni. Dopotutto, quelle più grandi non hanno nulla a che fare con i social. Quando uscì Nomadland nelle sale, la prevalenza dei camperisti era anziana. Ora, le cose sono completamente cambiate. Strangolati dai debiti del college, da lavori sottopagati e affitti stellari, tantissimi millennial sono finiti nei camper e non per girare video.
Di fronte alle disparità sociali, alle guerre e alle pandemie, il nomadismo sembra una risposta, proprio come lo è stata per gli hobo o gioventù bruciata. Giovani, adulti e anziani hanno sempre più bisogno di inseguire il circuito dei lavori stagionali, pur di mantenersi. Il problema è che anche il nomadismo è un privilegio. Non solo perché i camper e la benzina hanno un prezzo, ma perché serve essere bianchi.
Durante questo articolo, ho provato a distinguere la figura del vagabondo da quella del viandante. La riassumo di nuovo, con un semplice accostamento. Pochi giorni fa, mi è apparsa la notizia di un manager che ha cominciato a vivere in camper. Non ha abbandonato la sua azienda, era ancora un turbocapitalista, ma su quattro ruote. Centinaia di commenti lo applaudivano per il suo coraggio e spirito d’avventura. Lo stesso giorno, un leghista a Firenze ha postato un video con una donna rom chiedendo agli elettori di votarlo per non vederla mai più.
Nomadland, appena uscito nelle sale, è stato criticato per l’assenza di camperisti di colore. Jessica Bruder, autrice del reportage, è stata rapida nel rispondere che per un afroamericano o un latino è pericoloso girare per l’America dentro un van. E ha ragione, perché un nomade di colore non evoca il romantico ricordo di Kerouac o del viandante sul mare di nebbia. Evoca, invece, Caino: l’assassino, il ladro, sporco e accattone.
Essere nomade significa attraversare confini, dogane, sbarramenti della polizia. Significa non essere visto come una minaccia da allontanare. Significa potersi permettere un camper, la benzina e i parcheggi notturni. Certo, è pieno di uomini e donne di colore che vivono nelle tende, nelle auto, nelle lamiere. Ma non potranno inseguire i tramonti dei deserti né arrivare fino a un raduno nomade e contare sull’aiuto di una comunità consolidata. Il nomadismo occidentale va visto per ciò che è: uno stile di vita, ma non ancora una risposta alle disparità del mondo urbano.