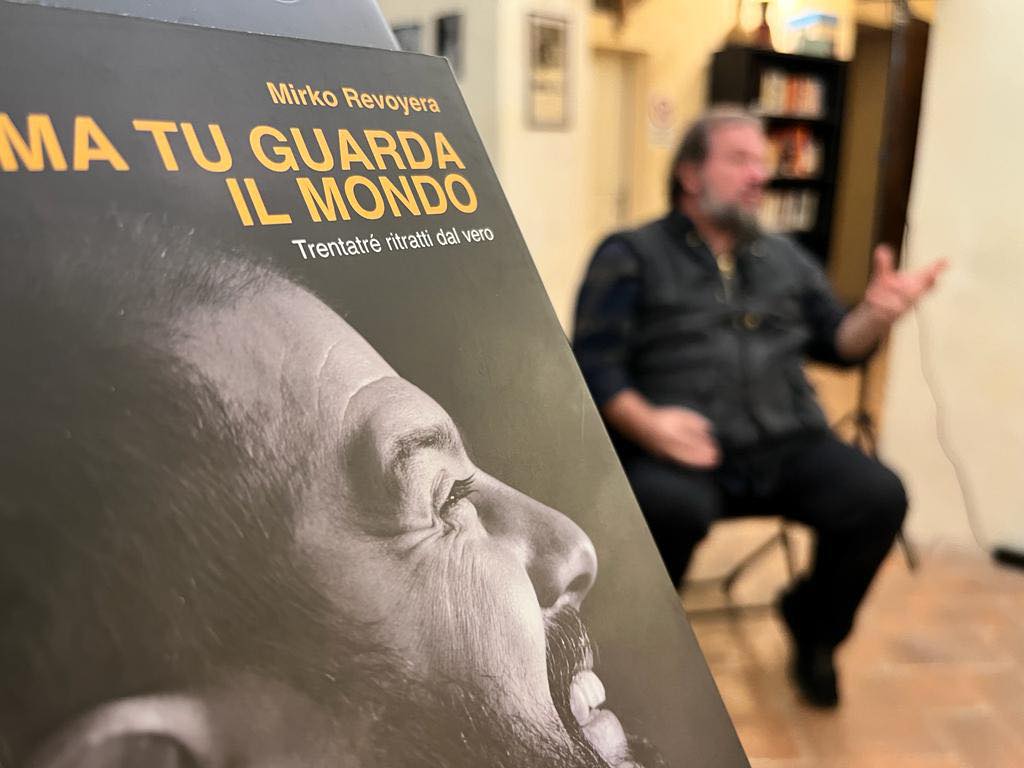Prima della rivolta. Cosa sta per succedere? Chi o cosa innescherà il sovvertimento delle leggi che regolano il mondo? Saranno gli uomini a ribellarsi all’oblio capitalistico a cui sembrano destinati o la Terra smetterà – una volta per tutte – di mostrarsi accogliente? A queste, e altre domande, prova a dar voce il romanzo d’esordio di Michele Turazzi, non nuovo al mondo dell’editoria, ma per la prima volta alla prova del foglio bianco.
Protagonista del testo è la città di Milano, ormai laboratorio sperimentale per ciò che riguarda la narrativa contemporanea, una metropoli che si proietta verso l’alto con i suoi grattacieli e, al contempo, sprofonda all’inferno, con i problemi ormai atavici che l’avvolgono e scoppiano fino a non offrire più soluzione.
Prima della rivolta (nottetempo) è – come da definizione offerta dall’autore – un noir d’anticipazione del futuro che potrebbe avvolgere il capoluogo lombardo e, in generale, i grandi centri abitati. È il 2045, eppure sembra oggi, con la violenza fuori controllo, i rider sempre più aggressivi, i migranti climatici respinti al recinto che protegge i confini, gli omicidi illustri.
Un libro, quello di Michele Turazzi, che irrompe nel panorama letterario e attira l’attenzione non soltanto dei lettori già pronti al genere, anche se… a pensarci bene, quale genere? Lo abbiamo chiesto all’autore.
Michele, ho letto tantissime definizioni diverse sul tuo libro. Lo hanno etichettato come un giallo, un noir, un thriller. Io, però, non sono riuscito a optare per una sola espressione. Tu come lo definiresti?
«Soprattutto, si tira sempre in ballo la distopia. In effetti, io stesso ho difficoltà a offrire una sola definizione e credo si tratti di una commistione di generi diversi. La struttura vuole essere quella del giallo investigativo, le atmosfere globali sono più noir. Inoltre, appare un intrigo di tipo politico, sociale, che si lega, forse, all’immaginario thriller, mentre l’ambientazione è a metà tra immaginazione e anticipazione. Effettivamente, possono essere valide tutte queste sintesi. Io lo definisco un noir di anticipazione, che mi sembra lo descriva meglio. Tu cosa pensi?».
Io ci ho trovato un po’ tutte queste anime. Mi piace meno l’idea del thriller, se devo essere onesto. Se immagino un thriller penso a Liebermann e mi sembra piuttosto lontano da quell’ambientazione.
«Anche il ritmo, se ci pensi. Il mio è molto più dialogato. Sono d’accordo, thriller è quello che lo rispecchia meno. Non sono nemmeno un grande lettore del genere, non saprei lavorarlo a dovere».
Tu lo hai chiamato noir d’anticipazione. Il termine distopia, in effetti, ci va vicino, anche se, leggendo il libro, ti vien da pensare: “Beh mica tanto!”. Tutto quanto descritto suona piuttosto reale e contemporaneo, ovviamente enfatizzato, ma molto simile al presente. Ho letto di una città, Milano, che non è lontana da quella odierna.
«Mi fa molto piacere che tu lo dica. Era l’obiettivo. Volevo creare un mondo di impronta realistica, quindi, sì, spostato in avanti, ma verosimile, quantomeno una possibilità di mondo. Poi, ovviamente, è presente qualche elemento che è spinto un po’ più in là, verso il romanzesco, e deve divertire, appassionare. A proposito di distopia, non mi aspetto, in vent’anni, l’avvento della chiesa dell’apocalisse o che un movimento di tale portata diventi dominante nel Paese. Per il resto, ho cercato di dare forma a un universo realistico, mentre la parola distopia, secondo me, mette in luce solo un lato pessimistico, negativo della proiezione. Ho lavorato molto anche sull’architettura della città, sui progetti già in essere o quelli di cui si sta parlando, sono partito dagli spazi, altri me li sono inventati».
Infatti, te lo avrei chiesto più tardi, ma mi hai anticipato. Si tratta di una città che già è così, una città proiettata sempre più verso l’alto – le torri, i grattacieli, il giardino verticale – ma che, in realtà, si sviluppa verso il basso, quasi a rappresentare un’anticamera dell’inferno. Non so se sei d’accordo.
«Di sicuro, in questa immaginazione di città ci sono una serie di contraddizioni. Non so se hai fatto caso che il dibattito attorno a Milano si è spostato dall’attrattiva, da una corsa in cui tutti si affannavano per incensarla, a una narrazione ora opposta, negativa. Credo che il racconto che si sta offrendo adesso vagli una serie di aspetti che, se esplosi, possono portare al mondo che ho immaginato. Soprattutto il problema dell’abitare, delle differenze sociali, dell’impoverimento della classe media, lo svuotamento del centro da parte degli abitanti e l’uso e consumo di interi quartieri a vantaggio solo dei ricchi, l’espulsione del popolo verso le periferie. Si tratta, a mio avviso, di tematiche che possono ancora essere contrastate, ma che nel libro sono esplose, a cui non è stato effettuato – dal punto di vista politico – nessun correttivo».
Perché oggi, secondo te, si parla tanto male di Milano?
«Per certi versi è fisiologico che ci siano dei cicli narrativi nella descrizione di una città. Come è fisiologico che, in democrazia, ci sia un’alternanza tra centrodestra e centrosinistra al governo. Anche nella narrazione ci sono momenti in cui ci si affanna a osannare qualcosa e altri in cui, anche per reazione a delle lodi eccessive, si va di segno opposto. Gli elogi della Milano post-Expo e pre-pandemia erano assolutamente eccessivi, così come tutte queste critiche sono esagerate oggigiorno. Non è tutto negativo. Ci sono, però, due problemi che non possono più essere ignorati: il primo è quello dell’abitare, che dal Covid in poi è diventato drammatico. Senza nessun correttivo al mercato immobiliare, ciò che è successo è una corsa verso l’alto dei prezzi di qualsiasi cosa che sta mangiando la città e questo è un dramma realissimo. L’altro è quello dell’inquinamento, che tutto il Nord si porta indietro da tempo ma per cui non è stato fatto nulla in merito. Attorno a questi ci sono aspetti più o meno negativi, come l’inflazione che a Milano subiamo ancora di più, che dipingono la città solo di segno negativo, anche se non lo trovo giusto, nel senso di veritiero».
Come mai hai adoperato la scelta di un’indagine per omicidio come espediente? Una sorta di grande metafora, l’omicidio di un uomo illustre che, di fatto, è l’omicidio dell’intera città?
«L’idea di una narrazione che partisse da un’investigazione nasce dal fatto che io sono un lettore di gialli e noir investigativi con atmosfere di questo tipo. Conoscevo bene il mondo in cui mi muovevo. Poi, via via che scrivevo, l’ambientazione diventava preponderante rispetto all’indagine, per quanto quest’ultima non fosse solo un escamotage. Non nego che l’ambientazione poi mi abbia chiamato di più e le parti che mi è piaciuto maggiormente scrivere e rileggere in fase di editing sono quelle politiche, quindi più esterne all’indagine. L’indagine, a mio parere, veicolava meglio determinati contenuti, altrimenti avrei scritto un distopico puro o un saggio».
Di recente, un articolo di Graziano Gala su Il Domani osservava la Milano declinata dalla letteratura contemporanea e indicava anche il tuo libro tra gli esperimenti come, ad esempio, quello di Bianciardi anni fa. Quanto una scrittura sperimentale è per te importante per proporre questo tipo di storia e di ritratto della città?
«Quella con Bianciardi è una parentela che mi fa ovviamente piacere. La prosa di Bianciardi è molto felice, personale, frutto di una tipologia umana e di scrittore peculiare. Il lavoro sulla scrittura, per me, è stato notevole. Il libro ha subito varie stesure, alcune delle quali sono state sessioni molto concentrate da un punto di vista stilistico, anche molto lunghe. Il lavoro sulla lingua è stato importante. Nelle sue primissime versioni, il romanzo aveva molto più legame con i modelli del giallo, era una lingua più al servizio della storia di quella che credo si legga attualmente. Dopodiché, ho effettuato una serie di riscritture volte a levare, ho rimosso 200mila, 300mila battute tra una versione e l’altra. Erano cose inutili, molta gestualità, molti riempitivi, frasi logore, pensieri esplicitati del protagonista, e parallelamente ho cercato di dare espressività alla lingua, provando a offrire qualcosa di più anche al singolo termine. Sono lavori paralleli che hanno portato ad avere meno tempi morti nel testo. Per offrire più livelli di lettura al lettore serve una scrittura calibrata in un certo modo. Dovevo allontanarmi, poi, da una scrittura di servizio come ghostwriter, non è stato facile liberarmi di certi automatismi. Ho tolto un po’ di mestiere».
I temi di Prima della rivolta diventano centrali, quasi coprotagonisti: c’è quello dell’immigrazione, parli di migranti climatici, c’è un recinto da oltrepassare, una violenza urbana sempre più aggressiva, così come i rider impazziti; ci sono gli insetti sugli scaffali dei supermercati, i criminali sono in colletto bianco e tablet. Insomma, questo 2045 non è così distante dal 2023, è oggi.
«Era uno degli obiettivi far sì che fosse tutto molto realistico, molto probabile. Non volevo un libro di fantascienza, non ho nemmeno quel tipo di immaginazione, ho bisogno del dato reale. Sentivo la necessità di raccontare questo aspetto politico. A poco a poco che entravo nell’indagine, il mondo che frequentavo presentava talmente tante criticità che portarle avanti di vent’anni mi permetteva di mostrare le conseguenze a cui rischiamo di andare incontro. Paradossalmente, durante la scrittura, alcune questioni che sembravano remote sono diventate assai prossime. Un esempio su tutti è l’utilizzo della IA, che nel mondo di oggi è già più evoluta di quanto non lo sia nel libro. Dovevo essere sempre dentro a questo flow, ma il mondo era più veloce di quanto io non riuscissi a starci dietro».
Non so se hai scelto tu il titolo o è stato modificato. Prima della rivolta è una rivolta popolare, della Terra, insomma chi è che si sta per rivoltare in questo 2045?
«Per il titolo sono debitore ad Alessandro Gazoia. Io sono pessimo in merito, tutte le volte che provavo a pensarlo non trovavo qualcosa di inerente al mondo a cui stavo lavorando. Sono d’accordo, quello scelto è molto azzeccato. La rivolta è principalmente popolare e neo-socialista, ma sono talmente tante le pulsioni politiche che si incrociano all’interno del testo che credo possa essere abbastanza polisemico. Il lettore non sa quale rivolta sta arrivando e non sa se arriva. Allo stesso tempo è, come dici, la Terra stessa che non si dimostra più accogliente verso l’essere umano che la abita e l’ambiente è in antitesi dell’uomo. Prima della rivolta vuol dire essere a tanto così dal far succedere qualcosa».
Tu hai fiducia nel domani? Per Milano e il mondo intero.
«Vedi? Quando danno del distopico al libro, in effetti, mostrano gli effetti di ciò che potrebbe essere se non fermiamo questo declino. A mio avviso, non dico ci sia bisogno di una vera e propria rivolta, ma di una presa di coscienza che l’agire popolare non è più rimandabile o da delegare. Un movimento esteso e coeso contro lo status quo e i privilegi di cui ancora godiamo anche tanti di noi. Abbiamo ancora troppo da perdere per mettere tutto in gioco, e invece stiamo perdendo lentamente».