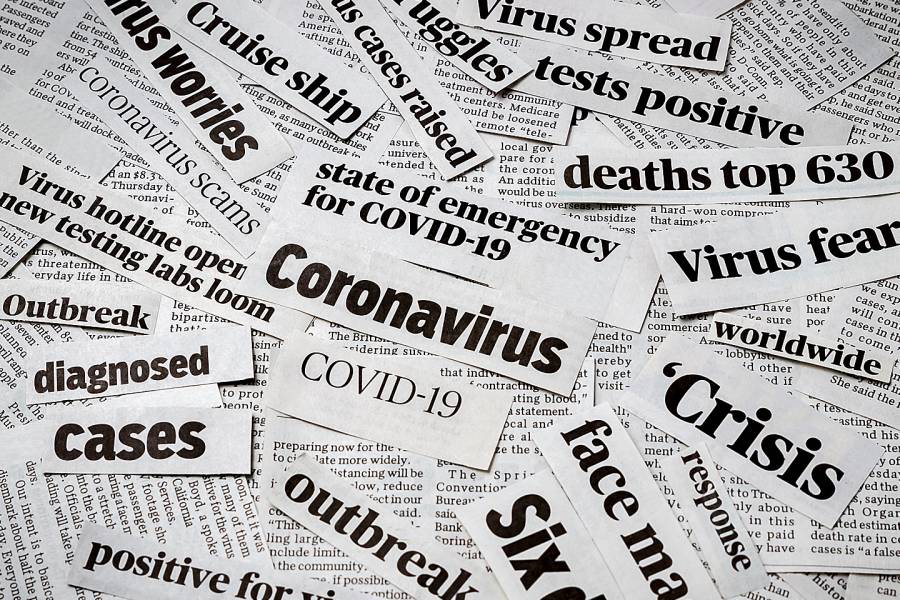Sono arrivata a Napoli nel settembre 2007. Abitavo su Corso Umberto, poi mi sono trasferita a Piazza Mercato. La città era affogata dai rifiuti. Prima di lasciare un piccolo paesino pugliese, tutto foreste e preghiere, le amiche di classe mi chiesero cosa avrei fatto dopo il diploma e quando risposi “vado a studiare a Napoli” mi guardarono come fossi pazza: tutte loro avevano scelto Roma, Milano, Bari, Campobasso.
Non si sceglieva Napoli agli inizi del 2000: era un luogo alieno, minaccioso, respingente. Nessuna delle persone che conoscevo poteva concepire di fare un weekend, una gita, di andare a mangiare una pizza a Napoli. Un cerchietto nero sulla mappa, da evitare accuratamente, come una macchia d’olio motore che se ti finisce sui vestiti è finita. Fa specie sentire una cosa simile se guardiamo alla contemporanea faccia della città: tutti vogliono visitare Napoli, tutti amano Napoli, tutti vogliono fotografare e fare servizi su Napoli. Per riassumere, Napoli è diventato il luogo da non perdere per essere alla moda.
Quando io mi trasferii, in un grande appartamento che condividevo con altre sei ragazze, i primi mesi furono terribili. Spesso di notte piangevo. Non mi mancava casa, fin da piccola ho sempre avuto un rifiuto patologico per i luoghi asfissianti, per le chiacchiere di paese, per il giudizio frutto dell’ignoranza. Fin dalle elementari sognavo una “città grande”, una qualsiasi. Ciò che mi tormentava era il pensiero che non fossi adatta a Napoli. Avevo la “città grande” che da sempre desideravo, ma io? Ero in grado di capirla? Sarei stata accettata? E avrei io stessa accettato un luogo immenso, difficile, così diverso dal grembo che mi aveva partorita? Ce l’avevo a portata di mano quella libertà agognatissima, eppure Napoli non voleva saperne di farmela acchiappare.
I primi mesi non feci amicizia con nessuno. Uscivo sola, con un taccuino e una macchina fotografica. Cercavo la scintilla, il dettaglio, la sferzata elettrica che mi avrebbe finalmente fatto dire “ecco, ho avuto ragione, ho scelto il posto giusto”. Quella sferzata non è mai arrivata. Napoli non mi ha conquistata con un gesto plateale, ma con un ritmo da lumaca. Quando me ne sono resa conto ero di nuovo a casa mia, in Puglia, per qualche festività: mi misi a letto, cercai di dormire, non ci riuscii, il silenzio era opprimente. Dov’era il clacson dei motorini? E il canto stonato del signore che portava a spasso una carriola carica di casse sfondate da cui partiva a quattromila decibel, che so, Rosario Miraggio, Mario Merola, Raffaello? Dove si era persa la voce del fruttivendolo all’angolo che chiamava il mio nome tre piani più in basso e mi diceva “jamme nennè, cala il panaro ché tengo che ffà”?
Già a quei tempi, quando c’era una partita del Napoli, capivo perfettamente il momento in cui stava per andare a segno un goal: mi affacciavo dal mio balconcino che dava su Piazza Santa Maria la Scala con un libro, due o tre sigarette, i piedi scalzi, e assorbivo il respiro prima del balzo. Prima di un goal la città tratteneva il suo spirito ridanciano ed eccessivo in polmoni di cemento. Quando il Napoli segnava la liberazione era assoluta. Ero contenta. Ma che tenevo da spartire io con il Napoli, con la squadra? Che mi importava?
Invece me ne importava, perché quell’entusiasmo mi permise di dimenticare i cumuli di monnezza, di aggrapparmi alla testarda convinzione che quello fosse il mio posto, la mia casa, che avessi scelto bene, come fa una madre quando decide di avere un figlio, non perché capita e basta, ma perché vuoi tutto, sempre, di più, più a lungo, più forte. Perché, nonostante da casa ti dicessero: “stai attenta quando vai in giro da sola”, “ma non hai paura?”, “secondo me non stai bene con la testa a vivere lì”, tu te ne freghi, ti innamori perdutamente, ti innamori dello sfasamento che ti provoca il contrasto tra luci e ombre, tra silenzio e caos, tra melma e diamanti, tra santità profana e laidezza che profuma di terra promessa. E lo fai ogni giorno, quando c’è da ridere e quando c’è da piangere, perché a Napoli si piange tanto, e non solo di felicità, ma di dolore, di rabbia, di livore represso.
Questo terzo scudetto arriva in un momento della mia vita in cui ho preso coscienza di quanto io sia legata a questa città: non si tratta solo di esorcizzare quella paura di essere inadatti a un luogo, ma di capire che la gioia provata in queste settimane è tanto autentica quanto quella di chi, a Napoli, ci è nato. Partecipando ai festeggiamenti per la vittoria ho potuto realizzare quanto io mi senta parte di questo popolo, pur non sapendo nulla di calcio: non ero qui quando il Napoli vinse i suoi primi scudetti, non posso comprendere fino in fondo la devozione del popolo partenopeo per Maradona, ma il sentimento di euforia espresso va alla città stessa, non solo alla squadra. Non è tanto la vittoria calcistica che mi interessa quanto la felicità della gente, lo spirito di condivisione, il calore tutto meridionale per danze e feste e canti che durano per giorni.
A cavallo tra il 30 aprile e il 7 maggio mi è parso che a Napoli si fosse raggruppato il mondo intero: napoletani, campani, romani, milanesi, pugliesi, siciliani, francesi, spagnoli, scandinavi, africani, influencer, troupe televisive, giornalisti, fotografi. Erano tutti a Napoli, chi per passione, chi per devozione, chi per qualche “pagnottista” like al proprio canale YouTube, chi per un servizio lungo due ore (a questo proposito, a testimonianza della concentrazione di professionisti del settore in città, abbiamo incontrato Diego Bianchi di fronte all’Accademia delle Belle Arti. La puntata di Propaganda Live su quelle giornate in attesa dello scudetto è molto bella e ne consiglio la visione).
Tutti sono diventati tifosi del Napoli, all’improvviso. Allora ogni tanto, tra un fumogeno e un fuoco d’artificio, mi sono fermata a pensare alla mia Napoli del 2007: quanti degli ospiti che accoglieva per i festeggiamenti avrebbero tifato per la squadra e per la città in quegli anni passati? Quanti di quelli che portavano fieramente la maglietta di Maradona avrebbero difeso le strade, i diritti e la dignità della città sedici anni fa?
Non si tratta di selezione in base a una scala che a un estremo segna “straniero” e all’altro “nato a Forcella”: vorrei lanciare una riflessione sulla natura stessa di Napoli che si apre per tutti, anche per chi non ha mai preso le sue parti. Pur vero è che il calcio è un collante potente: la vittoria del Napoli è stata festeggiata in tutto il mondo e a quelli che dicono “che esagerazione, per soli tre scudetti fanno tutto questo casino” rispondo che la gioia è direttamente proporzionale alla rarità di un evento di questa portata. Non si vinceva da trentatré anni, cosa vi aspettate che si facesse? Se il Napoli avesse avuto, che so, venti titoli, l’abitudine alla vittoria avrebbe smorzato gli animi. Ma questo è non il ventesimo titolo, è il terzo, e dunque lasciateci gioire.
Scommetto che anche quelle mie amiche del liceo ora vorrebbero essere qui, le stesse che mi dicevano “cosa vai a farci a Napoli? Sei impazzita?”. Io sono andata a seguire le partite decisive ai Tribunali, ai Quartieri Spagnoli e a Forcella, perché non mi interessa la Napoli cool, non so che farmene dei video degli influencer che titolano Napoletano per un giorno: l’ho già detto e lo ripeto, non si è napoletani per un giorno. Lo si è per sempre, nei momenti in cui c’è da gioire e anche in quelli in cui c’è da soffrire, oppure mai.
Io sono qui ora, nonostante la monnezza, la polvere, il risvolto della medaglia, sono qui perché voglio stare qui, perché quella ragazza di diciannove anni ha avuto ragione. Allora quando mettete piede a Napoli fate attenzione: bisogna avere mille occhi, è vero, ma per non perdere tutto ciò che si nasconde sotto i suoi mille veli cangianti (per dirla alla Özpetek). Fate molta attenzione: Napoli non è un luogo per tutti. Napoli accoglie la massa, ma trattiene solo chi sa vedere, ma vedere davvero, come un setaccio a maglia finissima.
Napoli si sceglie. E si sceglie per sempre, non solo per un giorno di festa. E questa festa, per com’è arrivata, per come è stata attesa e fortemente osannata, non c’entra nulla con le questioni di riscatto sociale, di “vetrina” sul mondo: Napoli non ha bisogno dello scudetto come vetrina, Napoli è la vetrina, è il negozio, è tutto il palazzo e il pezzo di cielo che oscura.
A Napoli non primeggia mai la regola del “se” ma del “quando”: non “se Napoli diventerà un polo attrattivo”, ma quando, e cioè ora; non “se il Napoli vincerà lo scudetto”, ma quando, e cioè ora; non “se la gente potrà mai capire quanta bellezza nasce e muore a Napoli”, ma quando, e cioè ora.
Sono arrivata nel 2007. La monnezza non c’è più e il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto. Avevo ragione e vorrò averne sempre.