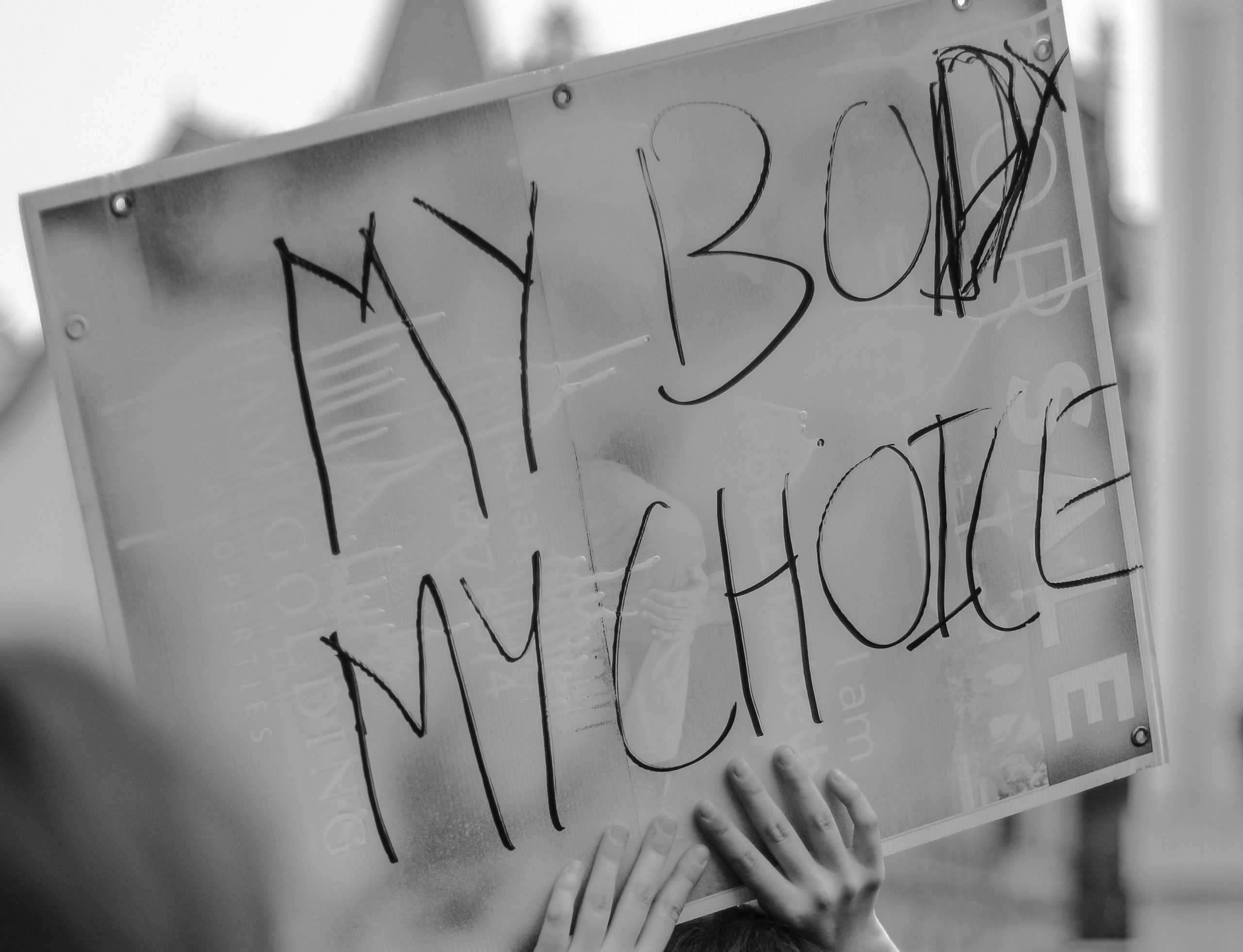Un mese fa, la prima condanna per reato di tortura – aggravata perché commessa da un pubblico ufficiale, un agente di polizia in servizio presso il carcere di Ferrara – ci ha dimostrato non solo quanto la previsione di questa fattispecie delittuosa fosse necessaria, ma soprattutto che gli istituti di pena possono diventare dei non luoghi, degli spazi su cui difficilmente si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica, per indifferenza nei confronti di chi vive oramai ai margini della società o nell’illusione che i detenuti vivano in luogo presidiato dallo Stato e, per questo, sicuro.
Eppure, dall’ultima vicenda processuale emerge che un detenuto, proprio mentre era sotto la custodia dello Stato, che – ricordiamo – ha un obbligo positivo nei suoi confronti affinché non subisca alcuna afflizione ulteriore rispetto alla privazione della libertà collegata all’esecuzione della pena detentiva, è stato torturato, picchiato e mortificato da chi a questo dovere avrebbe dovuto adempiere. Per la prima volta, si è parlato di tortura da parte di un pubblico ufficiale, dopo l’introduzione del reato nel 2017 – con non poche opposizioni e limiti nella definizione stessa – e sarebbe da ingenui ipotizzare che fino ad allora non si fossero già registrati simili miserabili avvenimenti.
Basti pensare ai fatti di Genova del 2001 e a numerose altre ipotesi in cui i giudici hanno affermato che si trattasse senza dubbio di tortura ma che non esisteva un reato adatto per la condanna, incriminando i colpevoli per fattispecie generiche e molto più blande. Il riconoscimento, dunque, è stato sicuramente un passo in avanti e lo è ancor di più se si pensa ai numerosissimi procedimenti avviati per fatti analoghi e ancora in corso. Ne è un esempio il processo iniziato per reato di tortura contro cinque agenti di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di San Gimignano, che avrebbero nel 2018 praticato violenze nei confronti di un detenuto, con la complicità di un medico dell’istituto che si rifiutò di visitare e refertare in merito alle sue condizioni.
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da uno stato di emergenza permanente che ha portato con sé un arretramento sul piano dei diritti fondamentali vissuto anche all’interno dei luoghi di detenzione, duramente colpiti dalla pandemia. Nel mese di marzo, allo scoppiare del COVID, in quasi tutti gli istituti penitenziari si sono registrate rivolte da parte dei detenuti, impauriti, senza notizie e nell’impossibilità di vedere i propri familiari. Quanto avvenuto in quell’occasione non solo era facilmente prevedibile, stante le condizioni delle persone recluse, ma soprattutto è stato effetto di una negligenza istituzionale il cui apparato non si è preoccupato affatto di informare in maniera completa la popolazione carceraria di quanto stava avvenendo e delle ragioni che stavano spingendo il governo ad assumere determinate decisioni. Durante gli scontri sono morti tredici detenuti – di cui cinque nel solo carcere di Modena e quattro nei trasferimenti da quest’ultimo verso altre carceri – il cui decesso è stato liquidato con overdose da farmaci, pochissime parole istituzionali spese a riguardo e nessuna risposta alle innumerevoli domande che pesano sulla coscienza di ciascuno di noi.
I detenuti, costretti a convivere con i propri aguzzini, non denunciano quasi mai le violenze subite da chi lavora e gestisce l’ambiente penitenziario per paura di ritorsioni e questa è una delle maggiori difficoltà che si trova di fronte chi ha tra i suoi compiti istituzionali quello di garantire la sicurezza e il benessere negli istituti. Molto più spesso le denunce arrivano dai familiari delle persone recluse, da altri detenuti che hanno assistito all’evento o da organizzazioni e associazioni che operano quotidianamente nei penitenziari e vengono a conoscenza di quanto avvenuto. I racconti delle violenze sono spesse parole flebili, intrise di rassegnazione tipica di chi sa che si tratta di un problema che riguarda l’intero sistema e non le singole mele marce di cui si sente tanto parlare. Sono i racconti di chi accetta il suo destino, di chi si rassegna all’idea di scontare una pena ben maggiore del reato commesso, di chi vive soprusi quotidiani sulla sua pelle e si sforza di celare la sua sofferenza di fronte alla propria famiglia.
Ma c’è anche chi ha coraggio, chi riesce ad alzare la testa e raccontare la verità con forza e determinazione. È quanto avvenuto pochi mesi fa, quando cinque coraggiosi detenuti hanno deciso, con un esposto, di dire la verità su quanto successo nel carcere di Modena durante la rivolta dell’8 marzo: violenze da parte degli agenti, un pestaggio di massa, manganellate in volto nei confronti di reclusi in evidente stato di alterazione psicofisica, anche dopo che questi si erano consegnati senza opporre alcuna resistenza. Dopo tali eventi sono stati messi in atto, nell’immediato, dei trasferimenti in altri istituti, senza effettuare alcuna visita medica e senza verificare che i detenuti fossero nelle condizioni adeguate per affrontare un viaggio, privati inoltre di scarpe e qualsiasi effetto personale.
Ma i cinque denunciatori hanno raccontato qualcosa di più: la morte di Salvatore Piscitelli, trasferito nel carcere di Ascoli Piceno, è avvenuta nel completo abbandono di quest’ultimo, senza che nessuno si preoccupasse delle sue condizioni o lo facesse visitare e nonostante le continue richieste dei suoi compagni di cella, anch’essi provenienti dal carcere di Modena. Attorno alla loro coraggiosa decisione si è poi avuta una mobilitazione pubblica, seppur irrisoria: sono stati organizzati dei presidi in città e, per l’8 marzo prossimo, anche a Roma. Inoltre, sono state inviate moltissime lettere di solidarietà, ma siamo consapevoli che la strada da percorrere per la verità e la giustizia sia ancora lunga. I mezzi d’informazione non trattano tali vicende, troppo preoccupati a salvaguardare l’immaginario di uno Stato sicuro e privo di responsabilità. I tredici detenuti morti sono stati corpi senza nome per moltissimi mesi, dopo i quali pochissime parole sono state spese al riguardo ed esclusivamente per la pressione proveniente da gruppi organizzati e collettivi.
Quanto sarebbe avvenuto durante le rivolte del carcere di Modena non è purtroppo un caso unico: basti pensare alla mattanza del carcere di Santa Maria Capua Vetere, per la quale sono attualmente indagati più di cinquanta agenti di polizia penitenziaria, o a quanto denunciato dall’Associazione Antigone riguardo al carcere di Milano Opera. Le denunce di abusi e violenze di questi mesi sono innumerevoli ed è molto facile ipotizzare che molti altri siano gli avvenimenti non emersi per paura, soprattutto se si tratta di persone straniere o sole. La ricerca della verità, in qualsiasi caso, dovrebbe essere una priorità dello Stato, i cui rappresentanti invece spesso si prodigano nella strenua e insindacabile difesa di chi avrebbe potuto compiere tali atroci atti. E se è vero che il diritto di difesa e la presunzione di innocenza sono prerogative di chiunque si trovi sul banco degli imputati, è anche vero che bisognerebbe evitare di dare per scontato che chi rappresenta lo Stato o agisce in suo nome non possa sbagliare o sia sempre mosso da buoni propositi e ideali. I fatti ci dimostrano molto spesso il contrario, essendo totalmente immersi in un sistema che fa della repressione e della paura i suoi baluardi.
La strada è lunga, ma la lotta per la verità e la giustizia è una responsabilità di tutti noi.