Vita e morte. Passato e futuro. Costruzione e distruzione. Il cantiere è, forse, la più emblematica metafora dell’esistenza umana. Uno sguardo a ciò che è stato e uno a ciò che potrebbe essere, un disequilibrio costante in cui destreggiarsi. È qui che nasce Nina sull’argine, il secondo romanzo di Veronica Galletta, edito lo scorso autunno per minimum fax. Ed è da qui che parte la nostra conversazione.
Protagonista è Caterina (Nina), giovane ingegnere emigrata al Nord alle prese con il suo primo incarico di responsabilità. Tra le difficoltà di una professionalità da costruire e i cocci di un privato ormai distrutto, il suo è un quotidiano dai ritmi sempre uguali, intervallato da momenti più intimi – ma mai banali – e incontri surreali. È questo, in fondo, Nina sull’argine, un romanzo sul lavoro ma, anche, un romanzo di fantasmi, quelli di Caterina ma non solo.
Siciliana di nascita, poi cittadina del mondo e ingegnere di formazione, con il suo primo romanzo, Le isole di Norman (Italo Svevo, 2020), Veronica Galletta ha vinto il Premio Campiello Opera Prima. La sua è una storia incredibile della letteratura degli ultimi anni. Ce la racconta di seguito, in una conversazione piena di cura.
Partiamo dalla tua ultima fatica letteraria, Nina sull’argine. Di questo romanzo si è già scritto tanto: c’è chi ne ha parlato come di un testo di formazione, chi come di un richiamo a un certo realismo magico di più antica memoria, chi come di letteratura industriale. E, in fondo, ognuna di queste definizioni ha un suo fondamento. Non trovi?
«Sì, sono d’accordo. In realtà, quando inizio a scrivere è per esplorare, comincio sempre un po’ al buio. E quando ho iniziato Nina avevo il desiderio di raccontare storie che conoscevo, motivo per cui una parte importante del libro viene fuori dalla mia esperienza. Sono laureata in Ingegneria, sono un ingegnere – un lavoro che ho svolto per tanti anni –, ho fatto anche lavori fluviali, marittimi, cose diverse. Sono partita da lì. Pian piano, costruendo, scrivendo la prima parte del romanzo, ho capito che volevo parlare anche di qualcun altro, di questo personaggio che Nina incontra nella buca, che è il motivo per cui, in alcune recensioni, si parla di realismo magico, anche se per me la definizione più corretta è “storia di fantasmi”. Credo, infatti, che siano tutti fantasmi in qualche modo, forse perché io vivevo quell’impiego come un fantasma. Anche quando ho cominciato a scriverne.
Quindi – dicevo – ho costruito una prima parte, poi la scena dell’uomo nella buca che Nina incontra, e così le due si sono incrociate. Via via, ho capito in che direzione stavo andando, quindi, sì, la letteratura industriale… Alcuni riferimenti mi sono venuti naturali, un po’ come delle coincidenze. La mia ambientazione ideale era una certa zona del canavese, poi ho scoperto che vi è ambientato il Memoriale di Volponi: sono quei clic degli scrittori che vivono di coincidenze, che ti fanno riconoscere da quale parte stai andando. Poi, sì, un riferimento molto grande è Primo Levi e La chiave a stella, che per me è un romanzo speciale».
La protagonista, Caterina sul lavoro, Nina nei suoi ricordi di vita privata, cresce in queste pagine e, insieme a lei, il cantiere che è stata chiamata a gestire, pur non senza difficoltà. Eppure, c’è un proverbio che a un certo punto le affidi: dove l’acqua passa, poi ci torna. Quasi come se a quel cambiamento non credessi fino in fondo…
«È vero, effettivamente… In generale, come essere umano non credo moltissimo nei cambiamenti e, inevitabilmente, riverso questa attitudine nelle cose che scrivo. Ricordo, per Le isole di Norman, una delle critiche che mi veniva mossa era: questo personaggio non cambia mai, non evolve. Io credo nella conoscenza di sé più che nel cambiamento, penso che ognuno, dentro di sé, abbia in luce tutte le strade che percorre. Un certo tipo di letteratura, o meglio, un modo in cui ci viene insegnata la letteratura, o lo scrivere, sostiene che i personaggi devono avere grandi archi di cambiamento, il punto di rottura, l’ambizione. Io, invece, credo che ci si muova a piccoli passi, quindi anche Caterina e Nina si muovono a piccoli passi, e non è detto che alla fine non si troveranno a dover ricominciare tutto daccapo.
Volontariamente, all’interno del romanzo, ho lasciato la protagonista con un’apertura e una chiusura, in qualche modo, circolari. Non sappiamo quanto sia cambiata davvero o quanto abbia imparato, può anche succedere che si alzi dal letto – nell’ultima scena è sdraiata – e chiami il suo ex compagno pregandolo in ginocchio di ritornare, non ci sarebbe niente di male se facesse una cosa del genere. La stessa cosa riguarda molto anche i lavori fluviali: ti insegnano che non sei tu a governare, è il fiume che decide. Devi osservare, osservare negli anni, fare un piccolo lavoro, vedere come si assesta, tutte le volte che pensi di poter governare un fiume succedono le grandi alluvioni. Non è come costruire un palazzo».
Nina è chiamata a costruire un argine proprio mentre intorno a lei, nel suo mondo, crollano le certezze: dalla fine della sua relazione con Pietro a un incarico che le piove addosso all’improvviso, tutto sembra cambiare ma non la sua consapevolezza di donna, di professionista ed emigrata. È lei l’argine?
«Sì, probabilmente per Caterina, per la professionista, l’argine è Nina, la sua parte interna. Per quanto contraddittoria, e portatrice anche di caos, volevo costruire una protagonista che non fosse una vincente, che sapesse come bisogna fare le cose, che le portasse fino in fondo e si facesse anche rispettare, che sapesse mettere i puntini sulle i. Però, in qualche modo, è Nina che l’aiuta, questa capacità di osservare che lei ha molto forte. È quella che le permette di giungere alla fine senza arrivare a uno scontro totale, ma riuscendo ad avere, in cantiere, un rapporto corretto con il geometra e con l’assessore e uno più duro con il funzionario della provincia. È Nina che l’aiuta in questa cosa, stare all’esterno e osservare, che è importante quanto le capacità tecniche. Li fanno gli uomini i cantieri, non si fanno da soli, e gli uomini possono avere problemi, la giornata storta, un capo che non li paga bene».
A proposito di argine come confine o come limite da superare da Nina in quanto donna e in quanto donna al comando. Anche nella tua formazione da ingegnere hai dovuto superarne tanti? E come scrittrice?
«Inevitabilmente. In qualche modo ti ci abitui, non so neanche se sia giusto, ma a un certo punto impari a utilizzarli anche a tuo favore. Ad esempio, sai che come donna puoi alzare molto di più la voce perché non verrà mai in mente, a nessuno, di alzare le mani, mentre a un uomo può succedere. Però, in alcune situazioni, la voce la devi alzare di più. Come scrittrice, invece, la mia è una storia particolare: ho fatto studi scientifici, non ho mai scritto nulla fino a quarant’anni, per cui sono entrata in un mondo che non mi apparteneva e che, a volte, tuttora vivo con ansia, con un complesso di inferiorità, perché recupero, scopro un libro e, invece, per chi ha studiato Lettere era un libro di testo, della sua formazione letteraria. Però, cerco di utilizzare questo mio limite come un vantaggio creativo. In questo, Primo Levi è una sorta di faro, cerco di pensare come pensava lui, che il suo essere chimico, il suo lavorare in fabbrica con le vernici, gli desse qualcosa di diverso. Poi, certo, c’è tutta la questione del sessismo in letteratura, ma andrei avanti…».
Nina sull’argine condensa certamente molti dei temi dell’attualità più stretta: la questione di genere – tra chi la chiama ingegnera o, peggio, signora per sminuirne la professionalità; l’ambientalismo e quella lotta sempre impari tra uomo e natura; c’è il lavoro e un modo di fare impresa che ignora il diritto; infine c’è una giovane iper specializzata eppure impreparata all’esperienza sul campo. Se, come hai dichiarato, Caterina è una porta su un microcosmo che altrimenti non avrebbe voce, possiamo dire che la tua prosa asciutta ma concreta è anche una critica alla società?
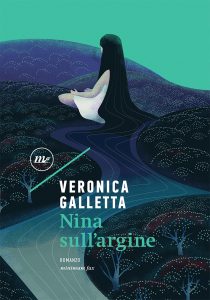 «Sì, sicuramente. È quello che mi ha spinto a scrivere questo romanzo, dopodiché ha attraversato, come me, varie fasi. Le prime stesure sono del 2013, l’ultima del 2021. Quel tipo di critica è andata asciugandosi, altrimenti avrebbe assunto soltanto i contorni dello sfogo, invece io ci tenevo che diventasse un romanzo. Desideravo proprio una storia di questo tipo, asciutta, al limite dell’anti-letterario. So di poter scrivere anche in diversi modi, l’ho già fatto, ma questa era la maniera con cui questo romanzo doveva parlare. Caterina, chiusa nei suoi pensieri, quando era nervosa doveva pensare cose tipo la vita è un casino, quasi come uno stato di Facebook. Volevo una cosa immediata, nervosa, non mediata. Le parti narrative e dialogate desideravo fossero così, secche, come sono i rapporti, come quando uno ti chiama signora e tu devi rispondere più volte per farti chiamare come è giusto che debbano chiamarti all’interno di un cantiere. Quindi sì, voleva essere una critica, anche se nel tempo tanto è cambiato. Questo romanzo parla di un periodo del 2004-2005, una quindicina di anni fa, prima della crisi economica del 2008. I rapporti in cantiere si sono enormemente incruditi rispetto ad allora, inevitabilmente. E poi c’è una donna, giovane, ingegnere, del Sud… anche questo, è un tema che esiste. Quando si parla di immigrazione ci si immagina la gente con la valigia di cartone. Quando vinsi il mio primo concorso, su diciotto che furono presi, diciassette erano meridionali arrivati in Pianura Padana con il treno della notte».
«Sì, sicuramente. È quello che mi ha spinto a scrivere questo romanzo, dopodiché ha attraversato, come me, varie fasi. Le prime stesure sono del 2013, l’ultima del 2021. Quel tipo di critica è andata asciugandosi, altrimenti avrebbe assunto soltanto i contorni dello sfogo, invece io ci tenevo che diventasse un romanzo. Desideravo proprio una storia di questo tipo, asciutta, al limite dell’anti-letterario. So di poter scrivere anche in diversi modi, l’ho già fatto, ma questa era la maniera con cui questo romanzo doveva parlare. Caterina, chiusa nei suoi pensieri, quando era nervosa doveva pensare cose tipo la vita è un casino, quasi come uno stato di Facebook. Volevo una cosa immediata, nervosa, non mediata. Le parti narrative e dialogate desideravo fossero così, secche, come sono i rapporti, come quando uno ti chiama signora e tu devi rispondere più volte per farti chiamare come è giusto che debbano chiamarti all’interno di un cantiere. Quindi sì, voleva essere una critica, anche se nel tempo tanto è cambiato. Questo romanzo parla di un periodo del 2004-2005, una quindicina di anni fa, prima della crisi economica del 2008. I rapporti in cantiere si sono enormemente incruditi rispetto ad allora, inevitabilmente. E poi c’è una donna, giovane, ingegnere, del Sud… anche questo, è un tema che esiste. Quando si parla di immigrazione ci si immagina la gente con la valigia di cartone. Quando vinsi il mio primo concorso, su diciotto che furono presi, diciassette erano meridionali arrivati in Pianura Padana con il treno della notte».
C’è una frase del romanzo che mi ha colpita molto: Non c’è scritto in nessun comma di nessun articolo di nessun decreto come trattare con la controparte quando le vite si incrociano, e si deve trattare con gli esseri umani. Tra i temi che uniscono i personaggi che si alternano sulla scena ci sono anche la solitudine e l’alienazione, siano esse volontarie o forzate. Nella tua esperienza di ingegnere e di scrittrice, quanto credi che nella vita come sul lavoro l’essere umano sia destinato a restare solo?
«Non lo so. Sicuramente il mio è un libro sulla solitudine, che, in qualche modo, è uno dei miei temi. Anche Le isole di Norman era un libro sulla solitudine e pure il romanzo che verrà dopo partirà da una situazione di questo tipo. Sul lavoro, anche in maniera un po’ goffa, ho cercato di dare, di restituire un rapporto di solitudini che comunque riescono a toccarsi, non a farsi compagnia ma a toccarsi, un rapporto “virtuoso”. È inevitabile, non c’è nessun comma che ti spiega come trattare con la controparte. Quando fai dei cantieri molto lunghi, alla persona dall’altra parte succede di tutto ed è una cosa di cui devi tenere conto. Nel libro, anche affrontando l’intimità di Nina, sono stata molto asciutta, non volevo un romanzo psicologico sul dolore, però è un elemento di cui tener conto, anche per una migliore riuscita del cantiere. La solitudine è un qualcosa che ci riguarda profondamente, si fanno insieme dei lavori tra tante persone che per un momento si possono incontrare. Bernini e Caterina, ad esempio, si ricorderanno della volta in cui sono andati a prendere un Bloody Mary insieme, è un momento in cui si dicono qualcosa in più, in cui le loro solitudini si incontrano.
Quando lavoriamo, quando li incontriamo in ufficio, vediamo gli altri sempre da fuori. Io, invece, volevo raccontare queste persone che di colpo si trovano da un’altra parte, con nuovi codici, che sono sole. Perché si sta soli. Quando vai in un posto nuovo a lavorare, con chi stai i tre giorni del fine settimana? Vai al cinema da solo, vai a mangiare da solo, ti iscrivi in palestra. Ti puoi rifondare. Personalmente, ho vissuto a Bristol, poi sono stata a Catania per un periodo, a Genova, a Parma, ora sono a Livorno, è un tipo di dinamica che ho visto spesso. Nei momenti di crisi quella cosa viene fuori forte».
A proposito, ho letto le pillole che hai scritto per minimum fax. Mi ha colpito l’immagine della tua scrivania paragonata a una nave, di come abbia dovuto spostarla di volta in volta…
«Sono contenta che ti sia piaciuta. Io scrivo queste cose e poi mi pento. Mi dico: “Hai scritto una cosa troppo mielosa, fai una cosa seria”».
Ma no, bisogna lasciarsi andare, sennò che si scrive a fare?
«Ma sì, è vero, hai proprio ragione».
La nebbia fa questo effetto, quando è troppa. Si trasforma in dubbio, e dentro il dubbio lo spazio diventa circolare, senza uscita. I dubbi che attanagliano Nina sono sicuramente tanti. Il cantiere, forse, lo è per eccellenza nella sua natura di “lavori in corso”, nel suo essere possibilità di vita nuova ma, anche, di mutamento e/o distruzione di ciò che c’è stato prima. Nina sull’argine è un romanzo sul passato e i suoi fantasmi o sul futuro, su ciò che può essere?
«Bellissima domanda. Non credo di saperlo esattamente. È un romanzo sul dubbio. Un cantiere è costruzione e distruzione allo stesso tempo. All’interno di Nina sull’argine la distruzione è messa in scena attraverso il percorso personale della protagonista, che si separa dal compagno e deve ricostruirsi. C’è poi la signora Bola, che si ritrova da un giorno all’altro davanti a un’opera che le cambia il paesaggio. Io non credo ci sia una distinzione così netta tra i fantasmi del passato e la costruzione del futuro, non puoi costruire senza tenere ben presente quali sono i tuoi fantasmi.
In Nina sull’argine, Antonio, l’operaio nella buca, è un uomo che la aiuta, un trait d’union con il passato. A parte la sua storia personale, la sua morte in cantiere, l’ingiustizia, è l’uomo che le spiega un certo tipo di tecniche molto banali, come guardare una difesa di sponda o capire se i carpentieri sono bravi oppure no da come tengono gli attrezzi. Quindi non puoi pensare a una costruzione se non pensi prima ai tuoi fantasmi, e la stessa cosa vale per la sfera personale; così Nina non può incontrare un altro uomo e ricominciare una storia con un’altra persona senza tenere conto di quali sono le sue personali fratture, quali sono le sue fragilità, le sue ossessioni sugli esami mai dati, quelli dati male, quello che è il suo personale fantasma: sentirsi sempre nel posto sbagliato. Quindi, c’è un legame forte tra le due cose. Spero che dentro il romanzo si veda, ma credo che molto dipenda da chi lo legge».
Hai dichiarato di aver voluto scrivere un libro sul mondo del lavoro. Nell’anno e nel Paese che registra l’ennesimo record negativo di morti bianche, cosa possiamo fare – intellettuali, ingegneri, cittadini attivi – per pretendere di riportare al centro del dibattito il tema della sicurezza sul lavoro?
«Pretendere soldi. Ci vogliono soldi per chi controlla e semplificazione delle norme. Dall’altra parte, ci vogliono vincoli. È un discorso molto tecnico, ci sono una serie di norme che consentono subappalti a cascata che, inevitabilmente, finiscono sulla sicurezza. La prima cosa che direi, quindi, è che servono soldi e persone e norme stilate da chi nei cantieri ci ha lavorato, ché, a volte, ti trovi ad applicare regole che non ci si capisce nulla. Bisogna portare la probabilità, l’incidente, al minimo possibile».
Caterina e Veronica sono due ingegneri donna, entrambe hanno lasciato la Sicilia e lavorano lontane dalla loro terra. Se la casa di origine di Nina è tuttavia un posto dove non ha lasciato niente. Né vestiti, né libri, né ricordi perché lei è una che ha scelto, cos’ha lasciato Veronica sull’isola?
«Molto interessante anche questa domanda. In qualche modo Nina, come Veronica, immaginava o supponeva di essere, negli anni in cui si è mossa, una cittadina del mondo. Più che cosa ho lasciato, cosa mi sono portata dietro: una certa abitudine alla flessibilità, che i siciliani hanno, al considerare il chiaroscuro, a sapere che c’è sempre questa doppia faccia, dove c’è il tragico, c’è anche il ridicolo. Credo di essermi portata dietro un po’ tutto, d’altronde ho scritto Le isole di Norman ambientandolo a Ortigia senza tornarci, come un’isola immaginaria. Credo di essermi portata dietro una certa capacità di adattarmi al mondo. O forse è solo vana gloria».









