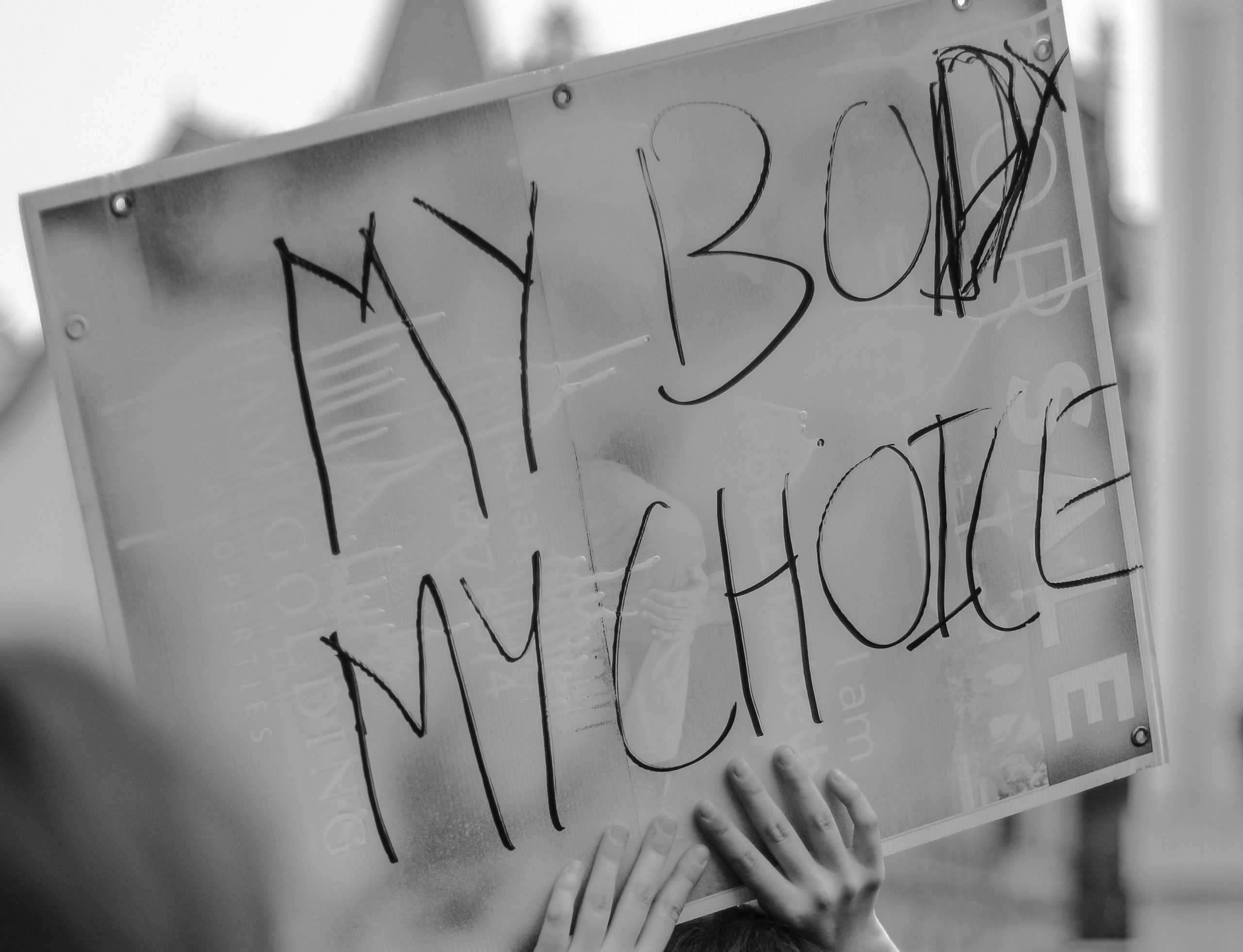In un mondo che regredisce, in cui ci sono ancora troppe dittature e non abbastanza tolleranza, in un’epoca in cui i passi indietro sono sempre il doppio dei progressi, risulta costantemente meno chiara la funzione della democrazia e il compito che la politica esercita all’interno del sistema democratico.
Democrazia, etimologicamente, significa che il potere è di tutti, risiede nel popolo. Che poi esso sia inteso come aggregato di singoli individui o entità astratta e collettiva che acquisisce valore nella sua interezza, è un’altra storia. Fatto sta che all’interno di questa forma di governo si garantisce l’esercizio del potere da parte di chi ha espresso il suo voto o la sua preferenza. Questo perché esercitarlo direttamente sarebbe impossibile e ricorrere a una rappresentanza diviene inevitabile.
Accade spesso, però, nella politica contemporanea, che l’eloquente significato etimologico della democrazia venga frainteso. Niente di nuovo, è vero, visto che per secoli il popolo si è identificato negli uomini liberi dell’antica Grecia e nella borghesia dell’epoca moderna, escludendo chiunque non facesse parte delle categorie privilegiate. Eppure, nonostante le conquiste del suffragio universale e del più semplice accesso a istruzione e informazione, resta difficile capire quale sia effettivamente il ruolo del popolo e quali i compiti dei suoi rappresentanti.
All’interno della fetta democratica di mondo, è importante che la minoranza governi insieme alla maggioranza. Un governo basato sulle esigenze dominanti diventa inevitabilmente una dittatura della maggioranza, portando a un governo dicotomico del tutto o niente, ma il compito della politica è rispondere ai bisogni di tutto il Paese, non solo a una parte di esso, per quanto grande possa essere. Destreggiarsi in modo equilibrato tra i diritti, i bisogni e il volere di ogni esponente dell’opinione pubblica, ma non solo. La politica deve fare il bene per i cittadini del presente, ma fare anche le scelte migliori per le future generazioni. Prestare attenzione a non sperperare le risorse economiche, creare piani a lungo termine, assicurarsi pensioni e sanità e non distruggere le risorse ambientali nel frattempo. Fare in modo che gli adulti del domani, i votanti del futuro, non siano danneggiati dalle decisioni dell’oggi. Ecco dunque il compito del rappresentate politico: non fare sempre il volere del popolo, o della maggioranza, ma fare il meglio per tutti. Certo, si tratta di un concetto non completamente oggettivo, ma definibile a grandi linee come decisioni che portano al giusto equilibrio dei bisogni di ognuno senza nuocere a nessuno.
È chiaro che in fase elettorale o pre-elettorale, durate campagne o referendum, la politica diventi un campo di battaglia, una lotta al consenso del più della metà. Ma non è sempre la maggioranza a poter decidere, a custodire le risposte alle decisioni difficili. Anzi, spesso la maggioranza, che si sente forte e legittimata, diventa cieca e tiranna e la politica deve saperne essere il giusto contrappeso.
Come interpretare, allora, le decisioni dei nostri politici? Come capire se agiscono per il meglio? Purtroppo, l’unica prova certa del loro agire sarà il tempo, che confermerà o smentirà la bontà delle loro azioni. Certo è che per garantirsi maggiori possibilità, non bisogna affidarsi solo al politico, al partito o al movimento che ha le idee più simili alle nostre, ma fare riferimento alle giuste competenze. Assicurarsi che chi parli di politica abbia studiato politica, che chi parli di sanità sia consapevole delle esigenze del sistema, che chi si occupa di istruzione abbia studiato abbastanza. Non si tratta solo di idee e di abilità, ma della giusta conoscenza, quell’esperienza teorica e pratica che istruisce e che permette di rendere in grado di svolgere un determinato ruolo, al fine, appunto, di garantire democrazia.
Quello del politico è un mestiere come gli altri per il quale è necessaria la preparazione adeguata. Quindi, per giudicarne l’operato, bisogna andare al di là delle ideologie di appartenenza partitica e tener conto delle capacità decisionali, dell’abilità nel risolvere problemi e affrontare crisi. Del grado di studio e del campo di applicazione corretto. Insomma, non deve solo piacere il carisma ed essere apprezzabile il modo di comunicare. Nelle sue mani si rimettono le decisioni prese per tutto il popolo, di oggi e di domani.
Nonostante siano finiti i tempi della propaganda, dell’uso passivo dei mezzi di comunicazione da parte degli utenti, purtroppo, è ancora il tempo del loro uso non del tutto consapevole e il rischio di manipolazione mediatica è tutt’altro che passato. Ma in un’epoca in cui non dovrebbero più bastare le idee simili e gli slogan accattivanti per aggiudicarsi un voto, più giudiziosi e più severi dovrebbero essere anche gli occhi di chi esprime preferenze. Perché prendere decisioni per tutto il popolo non è un compito semplice, ma neanche delegare va fatto con leggerezza.