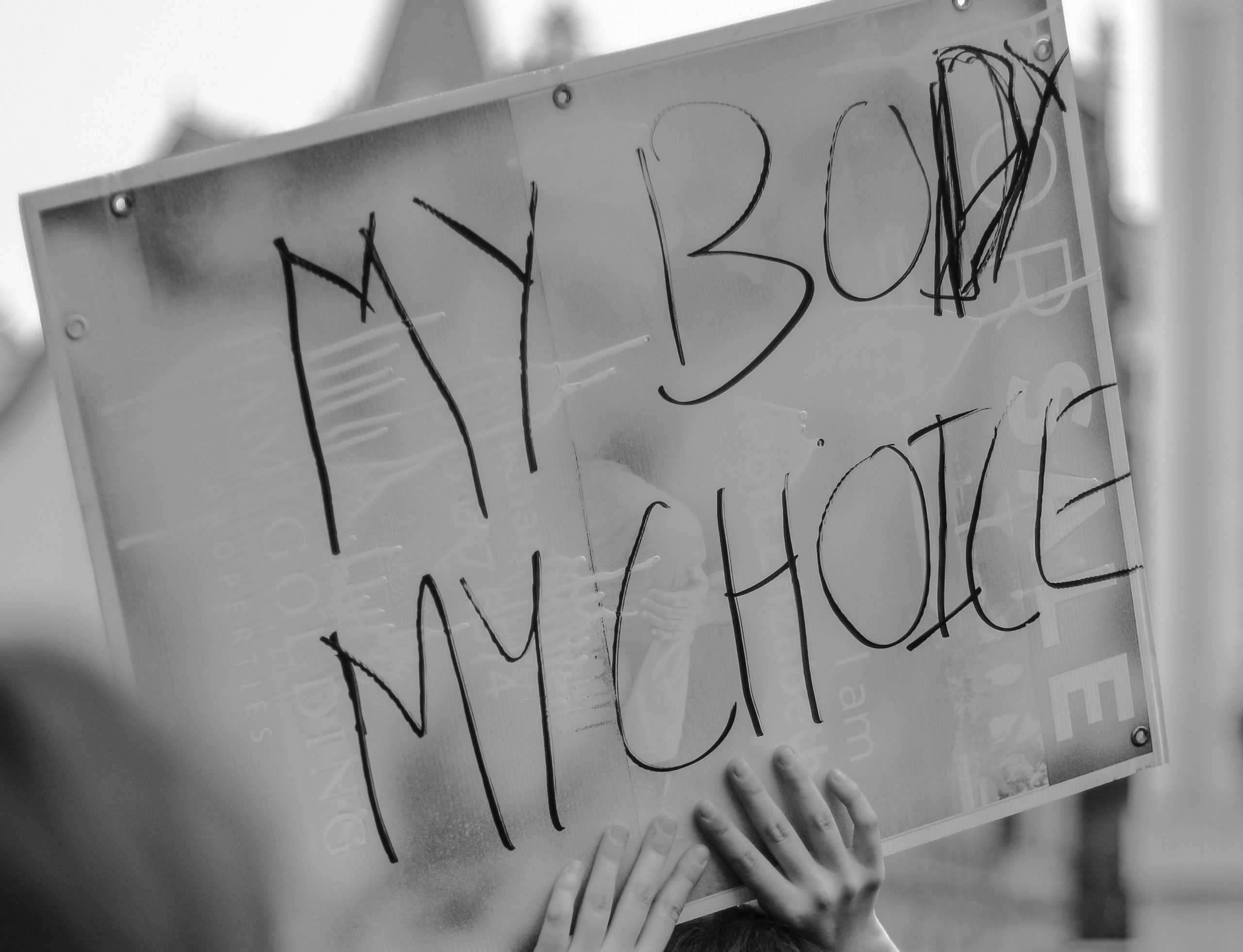La scorsa settimana, la Corte di Assise di Massa ha assolto Mina Welby e Marco Cappato dall’accusa di istigazione e aiuto al suicidio di Davide Trentini, rispettivamente perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato. Il cinquantatreenne, affetto da sclerosi multipla, aveva infatti deciso di mettere fine alle proprie sofferenze ricorrendo al suicidio assistito in Svizzera il 13 aprile del 2017, accompagnato dalla Welby e sostenuto economicamente da Cappato, tesoriere e copresidente dell’Associazione Luca Coscioni, attraverso l’Associazione Soccorso Civile. I due si erano immediatamente autodenunciati, ben consapevoli di aver violato l’ordinamento giuridico italiano.
L’articolo 580 del Codice Penale, infatti, punisce con la reclusione da cinque a dodici anni la condotta di chi determina l’altrui suicidio, ne rafforza il proposito o ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione. Eppure, Welby e Cappato avevano atteso con serenità la sentenza fermamente convinti della necessità del loro atto di disobbedienza civile. D’altronde, si tratta di questioni che periodicamente tornano al centro del dibattito pubblico senza però fare reali passi in avanti verso l’autodeterminazione del singolo a causa della loro complessità e dei piani etici e morali che intersecano. Non esiste infatti un diritto di morire speculare all’inviolabile diritto alla vita, tuttavia esistono situazioni in cui l’autodeterminazione e la volontà dell’individuo sembrano essere gli unici strumenti utilizzabili, non potendo nessun giudice sostituirsi nella valutazione di quale vita sia più o meno degna di essere vissuta.
Lo scorso anno, il 22 novembre 2019, la Corte Costituzionale era intervenuta sull’argomento, affermando l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputi intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano verificate da una struttura del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. La Consulta aveva quindi ammesso entro certi limiti il suicidio assistito e l’aiuto allo stesso, puntualizzando però che fosse necessario un intervento legislativo in materia che mettesse fine ad ambiguità ed eventuali discriminazioni. Il caso in oggetto riguardava dj Fabo, tetraplegico, che aveva deciso di mettere fine alle sue sofferenze con le stesse modalità di Trentini, accompagnato proprio da Marco Cappato.
Le motivazioni della decisione non sono state ancora depositate ma sembra che sia stata accolta l’argomentazione in base alla quale il requisito della presenza di trattamenti di sostegno vitale non è limitato all’utilizzo di macchinari, ma anche a trattamenti farmacologici e di assistenza la cui interruzione, nel caso di Davide Trentini, avrebbe portato alla morte. Come sostenuto anche dai due imputati, l’allargamento delle condizioni è sicuramente un importante passo in avanti poiché limita la discriminazione fondata sulla tecnica con cui si è tenuti in vita. Ciononostante, rimane necessario un intervento del Parlamento che – hanno tenuto a ribadire anche subito dopo l’assoluzione – è un grande assente politico sul tema dell’eutanasia, a dispetto delle continue sollecitazioni intervenute da più parti.
Al momento, l’unica legge in vigore in Italia sul tema del fine vita è quella sul testamento biologico, introdotta nel gennaio 2018 con il nome di Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, in base alla quale nessun trattamento può essere proseguito o iniziato senza il consenso libero e informato della persona interessata che può rifiutarsi preventivamente anche se questo dovesse procurargli la morte, come nel caso della nutrizione o idratazione artificiale. Rimane invece illegale, oltre al suicidio assistito, anche l’eutanasia attiva, in cui il medico non si limita a sospendere le cure o spegnere i macchinari che tengono in vita la persona, ma somministra un farmaco finalizzato a mettere fine alle sue sofferenze.
I piani morali e personali coinvolti sono molti, molto spesso collegati a credenze di carattere religioso. Tuttavia, come sostenuto anche in casi giudiziari diventati simbolo quale quello Englaro, l’indisponibilità e l’irrinunciabilità del diritto alla vita sono sanciti per evitare che qualcuno di diverso da colui che deve vivere si arroghi il diritto di interrompere la vita altrui. Per chi sia cosciente e capace di volere, la prima garanzia del proprio diritto alla vita risiede nella libertà di autodeterminazione rispetto all’ingerenza altrui, ove pure consista in una cura da erogarsi in nome del mantenimento in vita. Quest’ultimo, infatti, non può essere considerato un interesse pubblico o collettivo, distinto e sovraordinato a quello della persona che vive. Ovviamente diverso e ancora più complicato resta il caso di chi sia incapace e la cui volontà può essere soltanto dedotta, a meno che non siano state formulate delle disposizioni anticipate con cui si possono escludere i trattamenti di sostegno vitale nel caso di propria futura incapacità.
Alla luce di questa analisi, dunque, si conferma urgente l’apertura di un dibattito pubblico serio che metta al centro l’autodeterminazione e la volontà del singolo, come si confà a un vero Stato di diritto laico che non può arrogarsi il potere di decidere quali vite meritino di essere vissute o di lasciare ai giudici tale onerosa incombenza. È tempo di agire.