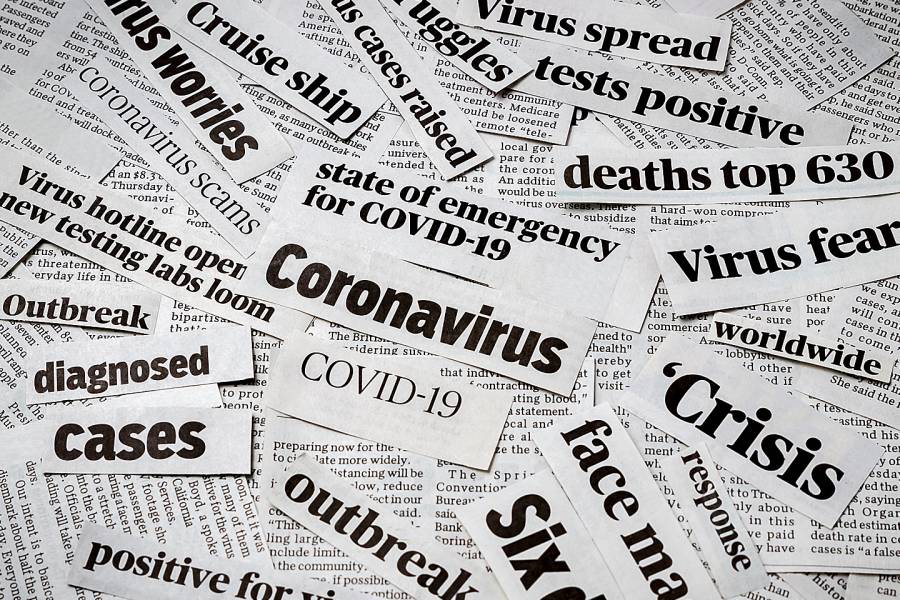Uscito recentemente sulla piattaforma Netflix, La caduta della casa degli Usher è senza dubbio uno dei migliori prodotti seriali a tema horror degli ultimi tempi. Dopo i successi di The Haunting of Hill House (2018), The Haunting of Bly Manor (2020) e Midnight Mass (2021), il regista e sceneggiatore Mike Flanagan torna sulla cresta dell’onda con una ennesima miniserie ispirata a un’opera letteraria, scomodando stavolta un pilastro della letteratura gotica e del terrore: Edgar Allan Poe. Un coraggio e un rischio non indifferenti.
Flanagan, però, aveva già dato prova di grande maestria quando aveva affrontato e trasposto prima L’incubo di Hill House, romanzo di Shirley Jackson del 1959, e dopo Il giro di vite, romanzo di Henry James del 1898, utilizzati per le due stagioni della serie The Haunting.
La caduta della Casa degli Usher (The Fall of the House of Usher) è dunque un racconto di Poe del 1839, sebbene i vari episodi – otto in totale – si ispirino a loro volta ad altri racconti o poesie dell’autore, ad esempio La maschera della morte rossa, I delitti della Rue Morgue, Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Lo scarabeo d’oro, Il pozzo e il pendolo e Il corvo. Ebbene, Flanagan è riuscito ad adattare e rielaborare le trame, ma soprattutto a cogliere la pura essenza del maestro conservando il proprio stile autoriale in maniera assolutamente impeccabile e unica nel suo genere.
La volontà è quella di descrivere e smontare pezzetto dopo pezzetto, episodio dopo episodio, la potentissima famiglia Usher, capitanata da Roderick Usher (Bruce Greenwood), amministratore delegato di una delle più importanti e ricche aziende farmaceutiche del suo tempo, la Fortunato Pharmaceuticals. Il patriarca e CEO decide di affidare le proprie confessioni al suo antagonista di una vita, il detective Dupin (Carl Lumbly), da sempre desideroso di incastrare il magnate. Da qui partiranno una serie di flashback rivelatori.
Flashback a proposito delle controversie sul licodone, potente antidolorifico venduto dalla Fortunato ma al centro di polemiche a causa dei suoi gravi effetti collaterali. Flashback a proposito della notizia da parte di Dupin di un prezioso informatore nascosto tra i membri della famiglia Usher. Ma, soprattutto, a proposito delle assurde morti dei suoi sei figli, una dopo l’altra, attorno alle quali aleggia la presenza minacciosa e costante di una misteriosa donna.
Flanagan mette in scena un interessante botta e risposta tra tre linee temporali differenti che si alternano in un ritmo impeccabile e mai ridondante: quella del presente, le confessioni, quella di un passato recentissimo riguardante la tragedia dei figli e quella di un passato risalente alla giovinezza di Roderick Usher e di sua sorella Madeline (Mary McDonnell), da una vita in miseria a un’altra immersa nel lusso e nella fama più sfrenati.
Sebbene l’intreccio possa sembrare complesso, a tratti inestricabile, tutto si snoda perfettamente verso la fine, anche il più piccolo dettaglio. Il merito va anche e soprattutto all’ottima sceneggiatura e a una regia efficace nei momenti giusti.
Ma non giriamoci troppo intorno. A rendere eccezionali i prodotti di Flanagan è l’incredibile cast ormai noto, grazie alla mania del regista – un po’ sullo stile di Ryan Murphy per American Horror Story – di utilizzare attori feticcio per trame differenti. Tornano sullo schermo Henry Thomas (sì, il piccolo Elliott di E.T. l’extra-terrestre), primo erede Usher, uomo patetico e odioso, o Kate Siegel, la quale interpreta la spietata Camille. Rahul Kohli è Napoleon “Leo”, mentre T’Nia Miller, stavolta, veste i panni di una dei figli illegittimi, Victorine. Abbiamo poi Samantha Sloyan (è Tamerlane), Sauriyan Sapkota come il giovane Prospero “Perry” e, in classifica ai primi posti, un grandioso Mark Hamill. Il suo Arthur Pym, fedele procuratore legale della famiglia, ha un nome che, forse potrebbe suonarvi familiare: si tratta di un ennesimo omaggio al protagonista di un romanzo di Edgar Allan Poe del 1838, Le avventure di Arthur Gordon Pym. E poi, inutile dirlo, lei, Carla Gugino, dea indiscussa qui più che mai. Verna, questo il nome della donna del mistero, ha un ruolo enigmatico e decisivo nella vita di ciascun personaggio, interpretato divinamente grazie al carisma espressivo che da sempre contraddistingue l’attrice.
Gli Usher precipitano dunque vertiginosamente, uno dopo l’altro, e lo spettatore sa che accadrà. Carta vincente di Flanagan, infatti, non è sorprendere con colpi di scena che non ti aspetti ma accennare l’accaduto e sviluppare poi l’intreccio attorno al fatto, mostrando pian piano il come e il perché, in un crescendo di tensione e curiosità da tenere letteralmente lo spettatore incollato allo schermo. Ci si ritrova a voler sapere proprio tutto della terribile famiglia Usher, dal passato di Roderick e sua sorella alle violente e fantasiose morti dei figli, una per episodio, i cui titoli rappresentano un simpatico gioco di associazioni per i più appassionati delle opere di Poe. Insomma, un bingewatching difficile da contenere.
Tra personaggi ed espedienti narrativi – molto suggestiva la scelta di inserire alcuni versi poetici dello scrittore –, Flanagan è stato in grado di omaggiare il maestro Poe firmando un’opera che ne riadatta la poetica senza snaturarla, prendendo ispirazione da varie fonti per poi creare una storia nuova, contemporanea. L’elemento gotico si distingue rispetto ai lavori precedenti, prezioso tanto quanto quello interpersonale, psicologico. Sono gli esseri umani e le loro contraddizioni i veri protagonisti dell’orrore, persone in questo caso ciniche e viziate fino al midollo, anaffettive, attaccate unicamente al denaro e al potere.
Non mancheranno momenti piuttosto inquietanti, spesso anche violenti e qualche potente jumpscare però ben contestualizzato. Un difetto de La caduta della casa degli Usher? Ha solo otto episodi.