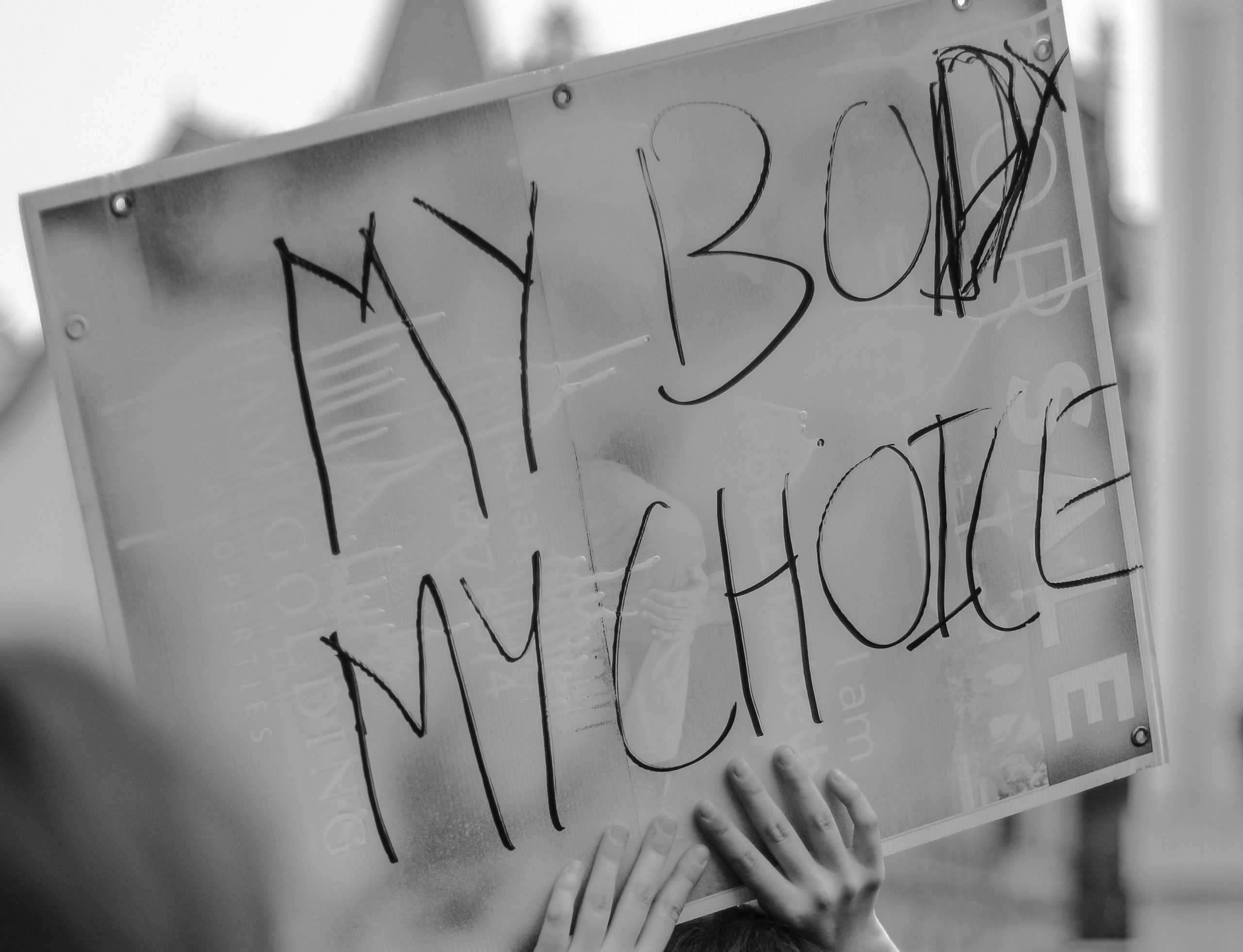Qualche tempo fa, mi trovavo in un centro congressi e ho assistito a una scena che mi ha dato da pensare. Mi sono recata al bagno, un bagno molto bello e altrettanto pulito, ben tenuto come poche toilette pubbliche, assolutamente niente a che vedere con quelle degli autogrill. Uno di quei bagni in cui ti aspetti di trovare ogni tipo di servizio: il pavimento pulito, la carta sempre disponibile, addirittura l’acqua calda. Insomma, un bagno da sogno, che se non fosse stato per il viavai continuo nemmeno avrei detto di essere in un luogo aperto a tutti. Entrando in quello delle signore, però, mi sono ritrovata davanti un uomo.
Un uomo vero e proprio, di quelli che rispettano tutti i canoni della virilità che la società impone per essere definiti tali. Alto, barba, felpa, peli sulle mani, insomma, un evidente uomo cisgender. Era circondato – ma non assediato – da quattro donne che lo osservavano. Nessuna di loro era scandalizzata nel vederlo lì, erano tutte intenerite. Per un secondo, non lo nascondo, anche io ho ceduto alla tenerezza, poi mi sono abbandonata alla rabbia.
Manca qualcosa, un piccolo dettaglio, perché questo racconto acquisti il senso giusto. Quell’uomo, che sostava già da diversi minuti nel bagno delle donne, forse un po’ in imbarazzo – anche se mi dava l’idea di uno che con l’imbarazzo aveva dovuto far pace già da cinque o sei mesi – quell’uomo che in altri casi sarebbe stato cacciato fuori a calci, stava in realtà usufruendo del fasciatoio per cambiare il pannolino della sua bambina.
Non è stato necessario mettere la testa fuori per notare che il simbolo del fasciatoio fosse presente solo sull’icona del bagno delle donne e ovviamente assente in quello degli uomini, perché tanto lo sapevo già. Ma sebbene non provassi alcun fastidio a sapere di quel maschio lì appostato nel bagno delle femmine, perché in quel caso ne riconoscevo la buonafede, non ho potuto fare a meno di pensare che può sembrare una piccola cosa la decisione su dove mettere – o non mettere – i fasciatoi, ma in realtà è proprio il fulcro di molti problemi.
La prima cosa che verrebbe in mente è quella discriminazione sistemica della nostra società nei confronti dei padri. Sì, esatto, i padri, quegli esseri mitologici che la narrativa vuole inesistenti nella vita dei figli, assenti fisicamente e, ancora più spesso, emotivamente. Quelle creature che di genitoriale hanno solo la severità di chi insegna le regole.
Il padre è quella sventurata figura a cui il figlio non appartiene, che per reclamarne la paternità può dargli solo il cognome e che, per quanto ci provi, proprio non riesce a inserirsi in quel rapporto duale e inscindibile che c’è tra madre e prole. A pensarci bene, il ruolo del padre – sempre a partire dall’impostazione fornita dal binarismo di genere voluto dalla cosiddetta famiglia tradizionale – non è cambiato particolarmente nel corso dei secoli: è chi impone disciplina e chi si assicura la sopravvivenza della famiglia, ma guai a dare un po’ di affetto.
Un padre, dunque, non può accudire. Se anche volesse, se anche ci provasse, non gli sarebbe permesso, perché la società sa imporre ostacoli di ogni tipo. Il maschio caccia, il maschio rimprovera, il maschio ringhia e rimette a posto, mica cambia i pannolini. Dunque non avrebbe senso, sarebbe uno spreco di risorse inserire i fasciatoi anche nei bagni degli uomini.
Questa impostazione della società, evidente dalle piccole – grandi – cose, ci ricorda che i padri non hanno il diritto di essere genitori. Non hanno il diritto né il dovere di accudire i figli né di volerlo fare, non hanno il permesso di essere presenti né quello di interessarsi. Questo piccolo particolare, rappresentativo di come funziona la famiglia – quella tradizionale, si intende – ci suggerisce qualcosa che ammettiamo con troppa leggerezza: che i figli sono una questione che interessa solo le donne.
Antropologicamente, il maschio deve assicurarsi la sopravvivenza dei suoi geni, dunque si riproduce solo per puro istinto biologico. Quello stesso istinto biologico lega il cucciolo alla madre finché non diventa indipendente. Quando, però, l’essere umano inizia a discostarsi dalle scimmie, evolve e diventa animale sociale, non c’è spiegazione antropologica che tenga – a meno che non voglia, certamente, tornare allo stato brado. E, quando l’evoluzione è completa, non ci sono giustificazioni per la sopravvivenza dei ruoli di genere. Perché l’evoluzione punta esattamente nella direzione opposta, verso una società che non funziona solo sulla base degli istinti biologici, perché sta lì la differenza tra uomo e animale.
Assodato questo concetto, questo superamento dello stato animale, non si può più dare per scontato che il ruolo dei genitori sia diverso e differenziato in base al loro genere. E nelle società evolute non dovrebbero esistere le differenze, neanche quelle apparentemente piccole e innocue, perché è lì dentro che si nasconde, invisibile e insidiosa, la disparità. C’è da chiedersi, allora, quale sia la distanza tra la creazione del gruppo delle mamme di classe e la richiesta rivolta ai padri di non partecipare alla vita dei figli. C’è da chiedersi perché i papà non abbiano i fasciatoi. C’è da chiedersi perché i figli di genitori separati siano affidati automaticamente alla madre. C’è da chiedersi perché a una donna che diventa mamma siano concessi sei mesi per accudire il suo bambino, mentre i papà devono farsi bastare solo dieci giorni per conoscere la nuova creatura a cui hanno dato la vita. La risposta a tutte queste domande è – ancora – terribilmente spaventosa: perché i figli sono delle mamme e perché le donne sono fatte per questo, per essere madri. Dei padri non ci importa granché.
Tirando le somme, forse non si può parlare, oggi, di diritti dei padri, perché il genitore maschio nella sua accezione comune non ha nessun ruolo nella vita del figlio. E dunque non ha bisogno di fasciatoi né di congedi parentali. Ma mentre agli uomini non è concesso assumersi il ruolo di genitore, alle donne non è concesso liberarsene. All’assenza dei diritti dei padri, infatti, non può che seguire l’assenza di diritti delle donne. Esistono solo i diritti delle madri che, attenzione, non coincidono con i diritti delle donne. Che rendono una donna meno appetibile professionalmente e dunque incapace di spogliarsi del ruolo di genitore anche quando genitore non è. Che, in qualche modo, cancellano la parità, perché lasciano intendere che la maternità sia l’unica forma di genitorialità accettata, caricando le donne di un doppio ruolo – di cui non riescono a liberarsi – che le inserisce, inevitabilmente, in una posizione di svantaggio.
Se gli uomini non possono essere anche padri, le madri non possono essere solo donne. Se un papà non può accudire il suo bambino, una mamma non può dividere il carico di cura. Ed è esattamente qui che risiede la disparità, ed è esattamente da qui che si dovrebbe partire per risolvere il problema. Nel suo saggio Il femminismo è per tutti, bell hooks affronta il tema della genitorialità come uno degli argomenti più problematici alla base della disparità di genere. Anche il rapporto di coppia, quello privato, e la divisione del lavoro di cura all’interno delle mura domestiche contribuiscono a creare la disparità. Anzi, forse è una delle cause principali, che poi si riflette in qualche modo anche all’esterno, nella società.
La disparità di genere è un problema contemporaneamente legale e culturale. Se i genitori non hanno lo stesso congedo parentale, uno dei due apparirà sempre meno produttivo e appetibile agli occhi dei datori di lavoro, ma allo stesso tempo se il lavoro di cura è affidato automaticamente solo a uno dei due, esso sarà sempre concentrato in quell’unico polo. È chiaro che la soluzione a questi problemi è molto più grande della posizione di un fasciatoio all’interno dei bagni pubblici, parte dalle leggi e dall’impostazione culturale, parte da un’ostinata sovrastruttura che stiamo appena scalfendo. Eppure, quella scenetta tenera e insopportabile del papà in uno spazio riservato alle donne ci dice tante cose.
Ci dice che le persone stanno pian piano cambiando e che, prima o poi, il cambiamento sarà richiesto anche sul piano formale. Ci dice che i papà vogliono o devono cambiare i pannolini dei loro bambini e la società prima o poi dovrà adeguarsi, perché posizionare il fasciatoio solo nel bagno delle donne evidentemente non basta a fermarli. Ci dice che gli uomini vogliono prendersi cura dei loro figli: magari perché sono genitori single, magari perché appartengono a famiglie omogenitoriali o, magari – e questa pare forse la cosa più inaccettabile – perché vogliono condividere il carico del lavoro di cura con le loro compagne. Ma ci dice, più di tutto, che c’è una correlazione inscindibile tra l’inesistenza del ruolo del padre e la persistenza ostinata della disparità di genere. Che un papà che non può fare il padre è il sintomo invisibile di una società in cui una donna che non può non fare la madre. E finché la genitorialità sarà imposta o negata in base al genere, non sarà possibile appiattire le differenze.